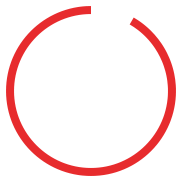Concorso Teatro in classe
Dopo l’ottimo esito dell’edizione conclusa, proseguirà Teatro in classe, il concorso promosso da Emilia Romagna Teatro Fondazione che offre agli studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori di Bologna e Provincia l’opportunità di vestire per un giorno i panni di critici teatrali.
Le classi seguiranno la stagione dell’Arena del Sole scrivendo per alcuni titoli in cartellone una recensione dello spettacolo e una rubrica di approfondimento che collega i temi trattati dalla messa in scena con l’attualità politica, sociale, culturale, di costume…
Le recensioni e le rubriche saranno valutate da una giuria di esperti che assegnerà importanti premi e riconoscimenti agli elaborati ritenuti migliori nel corso di una cerimonia di premiazione al termine della stagione teatrale.
I recensori saranno invitati a partecipare a Conversando di teatro, incontri con i protagonisti della stagione teatrale e a Wikiarena, approfondimenti sullo spettacolo che si sta per vedere.
Recensioni
Il cielo non è un fondale

Recensione
È una scena spoglia quella che si presenta allo spettatore. “Il cielo non è un fondale”, inscenato all’Arena del Sole, attraverso un’unica luce asettica che unisce palco e platea, fonde la realtà del teatro con quella quotidiana.
Entrati in sala, troviamo ad accoglierci lo sguardo attento degli attori sul palco, in uno spazio minimizzato, in cui la platea viene ridotta per favorire un “dialogo” intimo fra i personaggi e noi, tra cui non si frappone nessun sipario.
Gli unici elementi scenici sono un fondale nero, con il quale gli abiti neutri degli attori si confondono, e un termosifone bianco che sembra stridere con la semplicità dell’insieme, ma che nel corso dello spettacolo risulterà di grande importanza come metafora di un luogo accogliente che può diventare punto di incontro.
Non è presente un testo di riferimento, pertanto l’opera mette in scena esperienze di vita degli attori, basandosi sulla modalità di narrazione di Annie Ernau. Nei suoi testi l’autrice francese racconta avvenimenti della vita quotidiana partendo dalla propria biografia.
Nel corso dello spettacolo viene chiesto agli spettatori di chiudere gli occhi: questo vuole rappresentare un insieme di occasioni immaginative preziose, esattamente come quando leggiamo un romanzo e l’autore ci chiede uno sforzo di fantasia.
Lo spettacolo è interpretato dai quattro attori Daria Deflorian, Antonio Tagliarini, Monica Demuru e Francesco Alberici.
I primi due sono gli ideatori dello spettacolo che vede gli attori sempre presenti in scena, nonostante l’attenzione sia concentrata per la maggior parte del tempo alternativamente su uno dei quattro. Il copione obbliga gli interpreti a scene non particolarmente dinamiche, caratterizzate da monologhi statici interrotti da sporadici dialoghi e movimenti studiati.
Il confine tra attore e personaggio, come quello tra realtà e narrazione, non è percepibile allo spettatore, poiché i fatti narrati potrebbero essere veri o inventati.
La musica e l’aspetto sonoro, che si sposano perfettamente all’atmosfera minimale, sono affidati a Monica Demuru, cantante e rumorista vocale; inoltre, nonostante lo spazio adibito al pubblico sia ridotto, gli attori sono comunque dotati di microfono, al fine di rendere più intimo il rapporto tra palcoscenico e pubblico.
Tra i quattro interpreti spicca particolarmente Francesco Alberici per la sua bravura e naturalezza recitativa.
Nonostante le difficoltà a cogliere il messaggio finale dell’opera, è possibile comunque individuare i temi che gli attori hanno voluto trattare. Sicuramente è uno spettacolo a sfondo sociale con l’obiettivo di farci riflettere sul disagio del nostro presente, attraverso un’attenta ricerca del reale.
Come in un sogno, durante la rappresentazione, si passa da un tema all’altro attraverso il racconto di esperienze personali senza un’apparente successione logica e cronologica.
Il filo conduttore dello spettacolo, però, è la relazione con l’altro o con l’escluso e rivela il rapporto tra noi e ciò che ci circonda, partendo da ciò che siamo. Tutto ciò è visibile nelle scene attraverso le diverse modalità di comportamento dei personaggi. Le loro relazioni e i loro comportamenti con il prossimo si esprimono in modi totalmente diversi, in funzione di un diverso bisogno interiore basato su una profonda introspezione.
Rubrica di commento
Il cielo non è un fondale:spettacolo impersonale,confuso,senza alcuna barriera,in cui io spettatore “più capisco e più non capisco”.Nella scena un mondo frenetico,dove la casualità della vita viene ripresa nelle azioni dei personaggi,condizionati dalla fretta e dal tempo fugace,che non si soffermano su ciò che accade,né sul senso della loro stessa vita.Gli attori,consapevoli di ogni avvenimento,in un tale susseguirsi di eventi,vivono passivamente ogni giorno,trasportati dallo scorrere del tempo,e non riflettono sul perché delle cose;poi,però,si fermano un secondo,ascoltando una canzone,e il caos delle loro semplici vite ha finalmente una spiegazione. Grazie alla musica,infatti,ogni singolo personaggio riesce a soffermarsi,ad ascoltare i propri pensieri e a riflettere:si isola da ciò che lo circonda,dagli altri,da ogni suono e da ogni voce. Gli attori raccontano le loro esperienze in modo casuale,apparentemente senza seguire uno schema,così come tutto ciò che accade non rispetta un tempo o una scadenza,ma arriva inaspettato. Durante lo spettacolo ognuno di loro riprende una frase della canzone”La Domenica” di G. Truppi,che risulta chiara solo alla fine della rappresentazione, momento in cui il brano viene fatto ascoltare,ed è qui che le loro storie hanno finalmente un ordine e sono armonizzate tra loro nella sequenza dei versi.Ma come avremmo reagito noi in quelle situazioni,quanto siamo succubi e protagonisti del caso,cosa fare per cambiare le cose rispetto a quello che sono?
Classe IV D Liceo Enrico Fermi di Bologna
(coordinamento prof.ssa Francesca Colaci)
Totò e Vicé

Recensione
Scena buia , semplice, dominata da una panchina circondata da piccole candele, unica fonte di luce. Protagonisti, unici attori, due anziani immersi nel loro mondo: vivono di frammenti di sogni in un tempo impercettibile, legati da un’amicizia profonda, tutto quello che hanno.
Ciò che colpisce dei due amici è il loro genuino e innocente modo di vedere il mondo.
La loro semplicità li induce durante il corso dello spettacolo a porsi varie domande che hanno come tema centrale l’esistenza. Ma a queste non viene mai data risposta certa: rimangono sospese in una sorta di limbo senza tempo tra realtà e immaginazione, tra verità e finzione, tra la vita e la morte, che lascia spazio ai nostri pensieri…
La storia viene trasportata dall’immaginazione dei due clochard; i due ironici personaggi permettono alla scena, di per sé statica, di cambiare continuamente.
Grazie all’immaginazione si ha la possibilità di viaggiare nel mondo pur rimanendo stantii nella propria pozzanghera di vita quotidiana. Questa è una delle tante cose che insegnano Totò e Vicè.
“Ad occhi aperti riesco a vedere una piccola parte del mondo, se li chiudo lo vedo tutto”
Il forte legame tra i due protagonisti è la base fondamentale che utilizza l’autore per mettere in piedi l’opera. Un continuo botta e risposta che evidenzia la complementarietà dei due vecchietti dall’animo giovane. Il passato e il futuro si intrecciano tra loro attraverso analessi e sogni, i quali trattano di argomenti profondi e delicati che vengono sdrammatizzati, descritti e affrontati con ironia.
“Facciamo tutti e due gli stessi sogni”.
Totò e Vicè si considerino uno lo specchio dell’altro, quasi fossero la stessa persona. Totò dimostra in modo concreto il suo desiderio di voler stare accanto al suo Vicè ogni attimo della sua esistenza, accettando la morte e considerandola non come la fine, ma come un mezzo per ricongiungersi a lui. Alla morte di Vicè, infatti, Totò si dispera a tal punto da buttarsi giù da un dirupo. Le scene successive non si focalizzano più sulla vita e la morte, che passano in secondo piano, ma sui due protagonisti che continuano a giocare e a scherzare senza preoccuparsi di cosa li circonda.
Rubrica di commento
“Totò perché salti, alzi le mani, alzi le mani e salti?”
“Non me lo ricordo Vicè…”
Nello spettacolo i due protagonisti affrontano il tema della vita e della morte in modo bizzarro, slegati dalle convenzioni sociali, teneri ed infantili, testimoni di una triste realtà. Saremmo in grado di affrontare con la loro stessa semplicità la vita? La nostra realtà è ormai confinata all’interno di dettami sociali e di una coscienza collettiva che impregna sempre di più le nostre menti, quasi imponendo a tutti le stesse idee. Perché uno spettacolo che parla di una tematica, che dovremmo dare quasi per scontata, per noi è così difficile da capire? Da una parte ci sentiamo estranei completamente da questa loro realtà, diversa dalla nostra, ma dall’altra non riusciamo ad accettare che la realtà sia unica.
Un’amicizia, quella di Totò e Vicè, fuori da certi dettami sociali, genuina e sincera, dove entrambi riescono ad esprimere tranquillamente le proprie idee e i dubbi sulla realtà, un legame cosi forte che dà senso alla loro stessa esistenza.
“Totò che ci fai qui? Tu non sei morto”
“Sono qua perché io senza di te non esisterei”
“Totò e Vicè”rappresenta una realtà troppo vasta per essere compresa totalmente e una vita intera non basta per comprenderla.
Classe III B Liceo Enrico Fermi di Bologna
(coordinamento prof.ssa Francesca Colaci)
Medea

Recensione
Ritorna la “Medea” di Luca Ronconi
Lo spettacolo si apre con la balia dei figli di Medea che, seduta sopra un cumulo di borse e valigie, canta a squarciagola, mentre sul fondale vengono proiettati filmati di operazioni chirurgiche e paesaggi naturali. Quindi si sentono in sottofondo le urla di Medea, addolorata per il tradimento del marito, mentre il coro delle donne di Corinto ne è spaventato.
Quando Medea entra in scena, le donne si riuniscono attorno a lei per sapere cosa sia successo. Medea, avvalendosi dell’arte della retorica, riesce a convincerle della gravità del tradimento del marito Giasone, ed esse concordano sulla necessità della vendetta.
Entra quindi in scena Creonte, re di Corinto, il quale ordina alla barbara Medea di abbandonare la città. Tuttavia, fingendosi disperata e preoccupata per i figli, Medea ottiene un giorno di tempo prima di andarsene, un periodo sufficiente per attuare la sua vendetta sul marito.
Di seguito, si snoda un dibattito tra Medea e Giasone. La protagonista accusa il marito di vigliaccheria e minaccia di volersi vendicare, mentre Giasone prova a convincere Medea che il suo nuovo matrimonio con la figlia di Creonte aumenterà la tranquillità e la sicurezza dei loro due figli e della donna stessa. I due antagonisti si avvalgono dell’arte dei sofisti, la retorica, ben nota ad Euripide, per giustificare davanti alle donne di Corinto le proprie posizioni.
Medea , dissimulando i sui veri sentimenti e fingendo di non considerare oltraggioso il tradimento del marito, incarica i suoi due bambini di portare in dono alla principessa Glauce, figlia di Creonte e futura sposa di Giasone, un bellissimo peplo e una preziosa corona; si tratta in realtà di oggetti fatati che faranno perire chi li indosserà.
Infatti, poco dopo arriva un messaggero, che annuncia la morte di Glauce e del padre Creonte. Sopraggiunto ben presto anche Giasone, egli viene informato che Medea stessa ha ucciso i loro figli, per provocare il maggior dolore possibile al marito, vendicandosi in tal modo del suo tradimento, e per sottrarli ad una probabile punizione da parte degli abitanti di Corinto.
La celebre tragedia di Euripide, filologicamente rispettata nella lettera del testo, viene da Ronconi liberamente ambientata negli anni Cinquanta. Il personaggio di Medea è interpretato da Franco Branciaroli, che riveste i panni di una donna, quasi a sottolineare la psicologia distorta del personaggio; l’attore interpreta il ruolo in modo eccellente, con cambi di timbro vocale che mostrano la duplice personalità di Medea: apparentemente fragile e sostanzialmente spietata. Con la sua ingannevole maschera ornata di retorica, Medea riesce a convincere le donne di Corinto ad appoggiarla nei suoi piani efferati.
In un’intervista, Branciaroli chiarisce che egli non interpreta il ruolo di una donna, ma è un uomo che recita una parte femminile. Medea è un vero e proprio mito, una donna dotata di lucida e smisurata ferocia, che usa la sua femminilità come mezzo per commettere una serie di delitti mostruosi, finalizzati a garantire la sua dignità di persona, che non sopporta di essere calpestata da nessuno.
In conclusione, lo spettacolo di Luca Ronconi, ora riproposto da Daniele Salvo, suscita volutamente molti interrogativi anche scenografici: come mai l’azione è ambientata in anni recenti rispetto all’antica Grecia di Euripide? Cosa significano quelle iniziali proiezioni di interventi chirurgici e di paesaggi naturali? A ciascuno spettatore l’ardua sentenza. Certo, il grande teatro da sembre solleva dubbi più che pontificare certezze.
Classe IV P Liceo Enrico Fermi di Bologna – Aleksandr Trento, Augusto Arcidiacono, Leonardo Sportoletti, Matteo Lupo
(coordinamento prof. Ivan Montebugnoli)
Rubrica di commento
La“Medea” consente di individuare tratti comuni fra l’antica Grecia e il mondo odierno. Si pensi all’immigrazione: nell’antichità venivano disprezzati i “barbari” di lingua e cultura non greca, allo stesso modo in cui oggi noi discriminiano gli immigrati che avvertiamo come intrusi. Se Giasone tradisce e porta all’esasperazione Medea, con il pretesto che è straniera, parimenti oggi moltissime persone vengono uccise perché di etnia differente.
In secondo luogo, nella tragedia di Euripide si riflette sulla condizione di inferiorità sociale della donna, per quanto la maga della Colchide cerchi di ottenere con tutti i mezzi il rispetto dovuto. Oggi come allora la donna è fondamentale nella società, ma ciononostante è ben lungi dall’aver raggiunto la parità con gli uomini, per quanto molti diritti le siano stati riconosciuti grazie alle lotte femministe dei decenni passati.
Infine, tragico fra tutti gli altri orrori della “Medea” è l’infanticidio, commesso dalla madre “leonessa” sia per vendicarsi del marito sia per proteggere i bambini dalla prevedibile rappresaglia degli abitanti di Corinto contro chi aveva portato alla figlia del re il peplo e la corona che la hanno uccisa insieme con il padre. Ma anche oggi i figli vengono a volte uccisi dalla loro stessa madre per la paura di non riuscire a crescerli e a garantire loro una vita degna, in una società non sana e infestata di uomini violenti e poco affettivi.
In conclusione, per tanti aspetti, la società moderna non appare poi troppo diversa dalla realtà greca del 431 a.C. quale è descritta nella “Medea”. Anche da questo punto di vista, nihil sub sole novi.
Classe IV P Liceo Enrico Fermi di Bologna – Tommaso Bianchedi, Alexandra Gustomyasova, Radmila Marta Tomkova, Camilla Totti
(coordinamento prof. Ivan Montebugnoli)
Atlas des Kommunismus

Recensione
Atlas des Kommunismus è uno spettacolo toccante, reale e coinvolgente che immerge lo spettatore nei frammenti della vita di otto persone segnate dalla storia della Germania socialista. Entrato nella sala lo spettatore si trova a dover scegliere in quale scalinata sedersi: infatti la platea risulta divisa in due parti che si fronteggiano l’una all’altra. Il palcoscenico è posto al centro e, anch’esso, è diviso da uno schermo a frangia, che talvolta scende fino a terra, attraverso il quale gli attori hanno la possibilità di passare. La divisione scenica è fondamentale nel coinvolgimento del pubblico, che ha sempre una visione totale, davanti e dietro, indipendentemente dalla presenza dello schermo, alzato e abbassato per l’alternarsi delle scene; quando lo schermo scende, viene proiettato su di esso ciò che accade nella parte opposta del palcoscenico. Gli unici oggetti scenici sono sedie, telecamere, strumenti musicali e attaccapanni da cui i personaggi prendono i vestiti da indossare via via.
Lo spettatore si ritrova in un ambiente intimo, enfatizzato dalle foto proiettate, testimonianze della vita delle persone e dalla disposizione a cerchio delle sedie su cui i personaggi iniziano a raccontarsi. Di forte impatto ipnotico sono le luci intermittenti all’inizio della prima scena che poi cambiano in relazione ai racconti dei personaggi e alla musica che, cantata e suonata dal vivo, intervalla i racconti dei personaggi allentando la tensione.
Atlas viene proposto agli spettatori italiani in lingua originale, il tedesco, supportato dai sottotitoli che ne permettono una buona comprensione scenica e testuale. Lo spettacolo si snoda come raccolta di una serie di interviste sollecitate da una bambina, che con le sue domande dà un ritmo alla narrazione. Il linguaggio quotidiano accentua il carattere autobiografico dei racconti di vita dei narratori che ci mostrano differenti prospettive in relazione alla loro età e ai loro ruoli, cui fa da sfondo comune la storia della Germania socialista dal suo nascere al suo tramonto. È un teatro di realtà, dove spiccano le storie dell’attivista comunista di 83 anni che ha lavorato per la Stasi e poi si è pentita, della traduttrice che perde la sua posizione col crollo del muro e pena per ritrovare un suo ruolo nella società, della donna vietnamita che mostra tutta la fatica dell’immigrazione ieri e oggi, fino alla bambina che non ha avuto nessuna esperienza della Germania socialista ma s’interroga sulla sua eredità, su ciò che rimane.
Il cast dello spettacolo è composto da dieci personaggi di cui otto attori, un musicista ed un servo di scena.
Gli attori esplicitano subito il loro non essere attori, dichiarando le proprie narrazioni come autobiografiche.
Spicca la performance della bambina, Matilda, di dieci anni, che pone ai personaggi le domande che aiutano il pubblico a comprendere le singole esistenze e lo scenario storico di sfondo. E’ un elemento transgenerazionale, collante necessario tra gli spezzoni del passato/presente.
Il cerchio generazionale viene iniziato da Salomea, la donna di ottantadue anni, che legge appunti delle sue memorie e ci permette uno sguardo profondo sul fascino dell’utopia socialista e sulla delusione per il tradimento dei suoi presupposti di felicità.
La scelta di un cast quasi solo femminile esprime bene che non solo gli uomini fanno la storia ma anche l’altra metà del cielo: la polemica contro il maschilismo imperante nella politica è evidente, anche grazie all’unica figura maschile, Touckè, che si dichiara subito omosessuale, schierandosi dalla parte delle donne.
“Mi interessa il confine fra ciò che è reale e ciò che consideriamo come finzione, quel punto dove ci si accorge di stare sul limite”: questo dichiara la regista argentina Lola Arias. Così lo spettacolo si snoda alternando episodi significativi o simbolici dell’esistenza di ognuno dei personaggi, zigzagando nel tempo, confondendo la divisione tra presente e passato e quella tra realtà e finzione.
Il pubblico diviso sui due lati opposti del palcoscenico, diventa parte della divisione della Germania durante gli anni del muro di Berlino, ma è in comunicazione con i personaggi e con gli spettatori al di là del palcoscenico, grazie alle telecamere frontali che lo aiutano a vedere tutte e due le parti, davanti e dietro il “muro” appunto, la cui presenza viene sottolineata dal pannello su cui si proiettano i ricordi. Questa trovata visionaria ci trasmette, meglio di tante parole, il taglio chirurgico operato, con la costruzione del muro, sulla gente di Berlino.
Rubrica di commento
Dalla storia di Solomea, che decide di schierarsi al fianco della Stasi, realizzando poi di aver preso parte alla rovina del sogno utopico di un sistema socialista trasformatosi in uno stato di polizia, fino alla storia di Ruth, punk in lotta contro un sistema che da sempre ha percepito come oppressivo, le vicende dei vari personaggi di Atlas des komunismus, proposte come testimonianze autobiografiche, vengono messe in scena su un palco che divide e spezza il pubblico come un muro.
La forza visiva di questo spettacolo è dirompente, spiazzante: il muro è visibile, nella sua invisibilità, è di fronte ad ognuno di noi. E’ il muro concreto che divideva Berlino tra Est e Ovest, ma anche il muro simbolico di leggi, pregiudizi ed egoismo, come quello di cui parla Helena, quel muro che ai confini della fortezza Europa blocca i migranti in fuga da una situazione di guerra di cui noi stessi dovremmo sentirci colpevoli.
Lo spettacolo riesce a rivolgersi a tutto il pubblico, sia a chi la storia di quegli anni non la conosce e andrà a cercare le risposte ai propri interrogativi, sia a chi, conoscendo la storia, trova un punto di vista umano trasversale per riscoprirla e nuovi spunti per analizzare il presente.
Classe IV DL Istituto Enrico Mattei di San Lazzaro (BO)
(coordinamento prof.ssa Daniela Zani)
1917

Recensione
Lo spettacolo 1917 nasce da un’idea della compagnia teatrale ErosAnteros che ha origine dall’unione tra Davide Sacco, regista e music designer e Agata Tomsic, attrice e drammaturga.
In scena è presente solo un’attrice, che veste un costume di scena dalla forma particolarissima, in cui si intrecciano il bianco e il nero. Sul fianco sinistro dell’abito è presente una scala che allude a edifici tipici russi, diventati simbolo della rivoluzione. La recitazione è accompagnata da un quartetto d’archi (Nous ) costituito da tre violini e un violoncello, che riproduce continuamente la sinfonia n’8 di Sostakovic, riadattata da Davide Sacco. Il suono degli archi si interseca talvolta a brani di musica elettronica. L’attrice racconta la rivoluzione sovietica attraverso le parole dei poeti Majakovskij, Blok, Chlebnikov, Esenin, Pasternak e Geršenzon, i cui nomi sono scritti su supporti sui quali l’attrice recita.
La voce dominante è sicuramente quella dell’attrice, che usa il microfono per sovrastare la musica del quartetto d’archi che accompagna l’intera narrazione. Effetti sonori e alterazioni vocali sono utilizzati per variare il tono della voce.
La musica accompagna quasi tutto lo spettacolo, interrompendosi solo per dare più importanza alle parole dell’attrice ( allo stesso modo, talvolta, quest’ultima resta in silenzio per accentuare la rilevanza della musica ). Inoltre la musica rallenta o si velocizza a seconda del tono del discorso.
Nello schermo retrostante il palcoscenico vengono riprodotti disegni in movimento, che corrispondono all’argomento narrato, prevalentemente in bianco, nero e grigio, con qualche pennellata di rosso, giallo e azzurro. Le luci di scena sono utilizzate per rappresentare le diverse fasi della giornata: si accendono in corrispondenza del giorno e si spengono all’arrivo della notte .
I movimenti del corpo dell’attrice sono evidentemente molto studiati, tesi a imitare un andamento meccanico e accompagnano la narrazione con gesti ampi, creando quasi una coreografia. Il volto, pesantemente truccato, diviene estremamente espressivo e rispecchia l’ intensità delle parole, evocative e crude ( così come i testi ) che spesso adottano un linguaggio figurato.
Durante la narrazione l’attrice recita sopra diversi blocchi sui quali è riportato il nome dei poeti che essa interpreta, per questo è possibile allo spettatore riconoscere facilmente il passaggio da un poeta all’altro.
Lo spettacolo racconta la rivoluzione russa attraverso le voci dei poeti che l’hanno vissuta prendendone parte e perseguendo gli ideali di libertà ed uguaglianza in cui credevano.
Un racconto esaltato ed, al contempo esaltante, dove la rivoluzione acquista significati messianici e prefigura un mondo nuovo e “bellissimo”
Sceneggiatura complessa, ma supportata da una scena coinvolgente e curata, dai colori forti e dal ritmo incalzante. Suoni cupi, stridenti, che creano un’atmosfera di agitazione, cambiamento e attesa, rotta dal drammatico finale.
Uno spettacolo capace comunque di trasmettere emozioni, ma non per tutti. Non di facile comprensione in quanto, rinunciando ad una narrazione che contestualizzi i testi, preferisce esprimersi esclusivamente attraverso i poeti della rivoluzione. La poesia, infatti, di per sè, non dà una chiara idea dei fatti, e la chiave di lettura fondamentale è una conoscenza approfondita del contesto storico, che non tutti possiedono.
1917 è un modo nuovo e originale di raccontare un evento storico di impareggiabile drammaticità, che rinunciando a semplificazioni e giudizi moralistici, preferisce lasciare al pubblico qualche interrogativo.
Rubrica di commento
1917, nonostante un secolo ci separi dagli eventi raccontati nello spettacolo ancora oggi ill retaggio leninista permane nella Russia di Putin.
2018: tempo di elezioni, ma solo una “vera” candidatura per il Cremlino è stata avanzata, le altre rifiutate o con scarsa possibilità di vincere.
La fredda Russia non riesce a liberarsi da regimi autoritari, nonostante l’esperienza passata: tra Gulag e guerre civili, tra una rivoluzione e l’altra. Ancora oggi la situazione del paese è per certi versi, quasi la stessa di quella di un secolo fa: un solo uomo al comando che fa il bello e il cattivo tempo e una grande maggioranza della popolazione che subisce una politica autoritaria . Si capisce che quello che è accaduto nel non lontano 1917 non è servito quasi a niente, se non a cambiare il despota al comando. I comuni cittadini sono sempre nella medesima situazione, vessati dai soprusi di chi ha potere e privi di una reale possibilità di decidere sul proprio destino.
Nel 1917 nel clima della rivoluzione un’altra vera rivoluzione si è manifestata sul piano culturale e artistico: Majakovskij, Blok, Chlebnikov, Esenin, Pasternak e Geršenzon sono solo alcuni dei tanti artisti emersi in quel periodo di speranza, in cui sembrava che il tempo si fosse fermato e che questo sogno utopico potesse avverarsi.
Ma se loro opere sono la rappresentazioni dei desideri di cambiamento di tutto un popolo, negletti dallo scorrere del tempo e dalla storia stessa, le parole dei pensatori sconfitti possono davvero indicare la strada verso la felicità?
Classe IV B Liceo scientifico “ E. Fermi” di Bologna
Lorenzo Barbieri, Margherita Basile, Tommaso Bastia, Caterina Biagiotti, Alberto Bonazzi, Benedetta D’Angelantonio ,Ottavia Draghetti, Carlotta Fazzini, Lorenzo Filippin, Martina Galvani, Giulia Gialdini, Nikita Gori, Amari Ali Hade, Marta Lolli, Dario Lombardini, Mattia Marabini, Matteo Moreschi, Luca Riberti, Federico Santi, Federico Tovoli
(coordinamento prof.ssa Paola Poluzzi)
Peter Pan guarda sotto le gonne

Recensione
Lo spettacolo “Peter pan guarda sotto le gonne”, prima opera di una trilogia sull’identità di genere di Liv Ferracchiati, tratta il delicato tema del riconoscimento di sé , attraverso gli occhi ed il corpo di una ragazzina di undici anni e mezzo. Lo spettacolo si apre mostrandoci Peter che, volgendo le spalle al pubblico, rannicchiata su se stessa, mette in mostra il suo esile corpo. Spaesata e controvoglia inizia ad indossare il vestito rosa appeso di fronte a lei, che rappresenta una vera e propria gabbia, combatte contro un ruolo impostole dai genitori e dalla società, l’abito le sta stretto come il ruolo che le vogliono attribuire, indossa entrambi comunque, circondata da una mentalità chiusa e incatenata alle aspettative che controvoglia è costretta a rispettare.
Percepiamo nella protagonista una sensazione di disagio, imbarazzo e rabbia. Nasce in lei un senso di prigionia nei confronti del suo corpo femminile, portandola così a far emergere gradualmente, durante lo spettacolo, il suo lato maschile. Confusa, non sa chi è, ma sa di non voler crescere per nessun motivo, diventare adulti significa assumersi tutte le responsabilità. Contemporaneamente si sente soffocata dall’inconsapevolezza dei suoi genitori che non si pongono il problema che si possa sentire diversa. Gradualmente Peter inizia a ribellarsi vestendosi in modo più maschile e pian piano si innamora di Wendy, una ragazzina conosciuta ai giardini londinesi di Kensington, che sembra così grande e spavalda con i sui tredici anni. Gli stessi genitori, di cui non si vedono mai i volti, ma si ascoltano unicamente le voci che la schiacciano cadendo dall’alto, non lo accettano. Solo Thinker Bell, la stessa esuberante fata che lo ha aiutato a capire chi fosse, sembra incoraggiarlo, mostrandogli per la prima volta un futuro nel quale potersi rispecchiare, a differenza di quello che era stato programmato per “lei”. La fata -zainetto, Polaroid a sviluppo istantaneo, ali metalliche, gergo adolescenziale- funge da interlocutore tra la scena ed il pubblico, interagendo con quest’ultimo e portandolo a ragionare sulla differenza di identità tra corpo e mente. Questa diversità viene definita da Thinker Bell come normalità. La base musicale su cui si muovono gli attori, riconoscibile in un brano dei Pink Floid, non è stato un elemento particolarmente significativo.
Lo spettacolo ci mostra un punto di vista inusuale. Mette in luce aspetti di cui di solito, non si parla o si parla in maniera inappropriata. Riesce a trasmettere le sensazioni intime e i conflitti interiori che può provare una persona che percepisce in contrasto due parti diverse di sè. L’apice di questa lotta si presenta sul palco come una frequente apparizione dell’alter ego maschile della protagonista, contro il quale essa si scontra ripetutamente anche dal punto di vista fisico.
Alla fine, Peter indossa per un’ultima volta l’ormai vecchio vestito rosa e la sua risata cade a terra frantumandosi in migliaia di schegge, mentre si affaccia dalla finestra della sua camera, non sapendo se buttarsi o meno, lasciando a noi il compito di interpretarne la conclusione.
Vivere può essere difficile in una società piena di stereotipi e uguale a se stessa, una società che ci obbliga a sembrare ciò che non siamo, “Peter Pan guarda sotto le gonne” ci insegna a liberarci.
Rubrica di commento
Lo spettacolo di Liv Ferracchiati ci pone davanti a una tematica molto importante, l’identità di genere.
Alla nascita, in base alle nostre caratteristiche anatomiche, veniamo suddivisi in due grandi categorie ben distinte. Questa separazione, profondamente radicata nella nostra cultura e nella quotidianità, ci condiziona l’esistenza sotto ogni punto di vista.
Crescendo e relazionandosi con la comunità, alcuni di noi, faticano a riconoscersi nello stereotipo culturale dei generi.
Molti nascondono, anche oggi, la loro identità interiore per paura di non essere accettati, tale fenomeno era più diffuso nel passato perché l’intolleranza dominava sovrana. Il non rientrare in un modello convenzionale e precostituito, il non riflettere la propria immagine in ciò che gli altri hanno creato per noi causa un disagio profondissimo, che non ci permette di esprimerci liberamente.
Anche la famiglia, carica di aspettative, inconsapevole del peso e della sofferenza che provoca, indirizza l’adolescente verso una forzata identità.
I modelli convenzionali cambiano continuamente e vengono influenzati dai mezzi di comunicazione di massa.
Conoscere il passato dovrebbe portare la nostra riflessione a considerare la posizione dell’ermafrodita nell’antichità, simbolo di perfezione per la presenza contemporanea di entrambe gli attributi sessuali, baciato dagli dei in quanto vicino a loro.
Il nostro mondo guarda tutti attraverso le lenti dello stereotipo, negandoci la libertà di volare verso il divino…
Classe III N Liceo Artistico “ F. Arcangeli” di Bologna
Emma Baldazzi, Agata Bentivogli, Francesco Bertozzi, Giordano Eugenio Bornati, Santiago Calligari, Blanca Xiques Castro, Ludovica Dalla, Giada Demontis, Martina Epifania, Ludovica Fanini, Francesco Flora, Benedetta Gabella, Angela Iandolo, Chiara Sedili Innocenti, Shekinah Kyrah Isla, Ylenia Joiner Santurio, Benedetta Lambertini, Laura Lepore, Francesco Lutti, Matteo Mazzetti, Gaia Mereu, Noemi Muzzati, Alice Nassetti, Matteo Lucas Pirrone, Greta Polazzi, Daniel Saporita, Valeria Trillo Mozombite, Laura Zanna
(coordinamento prof.ssa Manuela d’Alanno)
Gioie e dolori nella vita delle giraffe

Recensione
Un grosso televisore in un parcheggio. C’è il canone da pagare, indispensabile per ricevere Discovery Channel (il canale della scoperta), per dare la possibilità a Giraffa (bambina di nove anni , assai alta per a sua età) di fare un compito scolastico sulle giraffe.
Che cosa è un compito lo sappiamo tutti, è ricerca, esplorazione, vagabondaggio, è avvicinamento alla verità e al contempo distanziamento e straniamento.
Siamo in un territorio di asfalto, un parcheggio di Lisbona ma potremmo essere ovunque perché tutti i parcheggi si somigliano come gli idealtipi della cultura underground che qui si incontrano e scontrano: il padre artista disoccupato , il vecchio dimenticato dai figli, l’emarginato, l’impiegato, il pupazzo di pezza Judy Garland che vorrebbe avere nome Cechov , Pantera (pensionato, impiegato, poliziotto ed infine primo ministro del Portogallo).
Sono esseri umani parcheggiati nella strada ruvida e fredda di una qualche zona periferica della società.
La rispettabilità della marginalità e delle problematicità riesce perfettamente nelle trasformazioni compiute dai quattro personaggi che entrano ed escono dai loro panni, dove le scelte assegnate e gli schemi necessari alla narrazione si riconvertono e si mescolano abilmente nel mettere a nudo non i loro corpi, ma le loro anime,
E’ nel parcheggio che dapprima si insedia la casa di Giraffa, è il tempo della sua infanzia, quando c’era e sua madre e dopo, quando morì.
La madre scrittrice rimbalza nei giochi linguistici e comunicativi della bambina, ne è il riflesso e la guida, si è trasposta in lei che orchestra la narrazione e le consente di recitare la vita, non il copione del testo .
Successivamente, quel luogo diventerà la strada, non-luogo di incontri che si incaricano di compensare quell’assenza (a loro insaputa), perché quando qualcuno e qualcosa sparisce ce lo portiamo per sempre nel cuore.
Succede anche alle giraffe. Anzi, è proprio in un cuore-giraffa così lontano dalla testa, che il vuoto può abitare più comodo e muoversi più agilmente.
Nella savana (parcheggio) zona di transizione tra foresta e steppa e deserto, dove la vegetazione arborea è rada e sparsa, gli organismi hanno sviluppato particolari accorgimenti per cavarsela nella vita e contano soprattutto sulla loro capacità di movimento.
Il vortice del recitativo degli attori produce spostamenti e incontri-scontri fisici e relazionali a cui danno intensità le sequenze ritmate della musica hip hop che si modella e si espande in forme diversificate, ricche di metafore musicali e linguistiche e per questo sociali.
Nel manifestarsi di allitterazioni, assonanze su basi ritmiche uniformi, cadenzate in rap\ funk\alternative rap siamo con loro nel parcheggio metropolitano e soprattutto con Giraffa mentre da corso alla sua ostinazione. E’ un’ostinazione sì, una di quelle che traghettano la crescita : qui l’obiettivo è raggiungere il primo ministro affinché legiferi sulla non colpevolezza del rapinare una banca!, quando si tratta di poter accedere ad un malloppo necessario al pagamento del canone televisivo. L’ostinazione si concretizza nell’impegno di Giraffa che non si risparmia per il conseguimento dello scopo : si tratta di poter accedere a Discovery Channel per poter scovare nelle sue trasmissioni le avventure da chi le ha vissute in prima persona.
Giraffa vuole evitare ricostruzioni fittizie, così come sanno fare i documentari e le ricerche di qualità e con pervicacia, vuole essere dentro e più vicina possibile ai fatti . Ci convince così (senza saperlo) anche sul piano umano, logico ed estetico: se la visione delle giraffe fornisce una percezione altra rispetto alla visione dello stesso luogo da terra, le gioie e i dolori permangono universali e lasciano tracce indelebili nell’asfalto e nei cuori.
Rubrica di commento
Gioca
Indomita
Ragazza
Avventurosa
Forse
Finalmente
Adulta
E’ la “favola” metropolitana “Tristezas e alegrias na vida das girafas”, del drammaturgo portoghese Tiago Rodrigues, la portavoce della realtà contemporanea.
Il percorso socio-culturale di Gioie e dolori nella vita delle giraffe inizia alla fine degli anni ’60 e incalza sino ai giorni nostri, in cui le sottoculture si mescolano e si influenzano a vicenda. Siamo in un parcheggio metropolitano che inizialmente evoca la casa di Giraffa( la bambina di nove anni , troppo alta per la sua età) al tempo della sua infanzia e della morte di sua madre. Successivamente il parcheggio è tutte le strade di Lisbona, anche se non c’è alcuna sensazione di cammino , di prospettiva o analisi lineare sulla crescita di Giraffa che annuncia : “questo è ciò che è avvenuto il giorno prima che sono diventata grande”. Si susseguono incontri caotici imbrigliati dagli stimoli interni ed esterni dell’esistere .
Nella corporeità della recitazione ci sono la musica, le icone immaginarie e il senso di ribellione che guidano la narrazione; ci sono gli stili di vita , i valori intrisi di vicende personali, di relazioni sociali e di politica in un incalzante riepilogo celebrativo delle subculture che, a partire dagli anni settanta sino agli anni novanta\duemila, hanno espresso antagonismi nella collettività attraverso forma di socialità non istituzionale.
I quattro personaggi si appropriano di connotazioni estetiche e iconografiche dell’underground punk , hip hop e rap e sono il padre artista senza lavoro, il vecchio dimenticato dai figli, l’emarginato,il pedofilo, il poliziotto, il primo ministro. Sono esseri umani parcheggiati in una zona periferica della società accomunati dallo stesso destino dell’orso di pezz Judy Garland o Pantera, portavoci anch’essi di identità multiple , della necessità di trasformarsi e mettersi ne i panni dell’Altro.
La rabbia verso la società è nella la musica veloce e sincopata, con tonalità acute e a volumi alti, è nel corpo vestito con catene e collari, è nei giochi del linguaggio e della comunicazione interpersonale e sociale che manifesta l’impossibilità di cambiare le cose ; è nella mancanza di libertà e di prospettive, è nelle forme di emarginazione e sarcasmo verso la società e la cultura dominante, in cui le questioni storiche ed umane, restano aperte e problematizzate, né si incaricano di indicare risposte definitive .
Il teatro, cosí inteso, realizza una funzione antica dell’arte , è strumento per l’osservazione e l’ interpretazione sociale della realtà, là dove le sue estremità sono raggiunte dai tentacoli del potere che ostacola il dispiegarsi delle esistenze . E’ il teatro che rende evidente allo spettatore di quanto egli sia sempre parte di ciò che osserva e costruttore responsabile dei significati della sua esperienza e se il teatro non può cambiare il mondo, può cambiare gli spettatori che, dunque, possono trasformare il mondo.
Giraffa ne fa sintesi in una battuta “Questo è il suono della decisione! ” e stringe la mano al grande T.S. Eliot “Noi che non fummo sconfitti solo perché continuammo a tentare”.
Classe III O indirizzo Economico-Sociale Liceo A.B Sabin
(coordinamento prof.ssa Mirca Buttazzi)
Il giorno di un Dio

Recensione
“Il giorno di un Dio”, spettacolo teatrale per la regia di Cesare Lievi, è una collaborazione tra il teatro di Roma e lo Stadttheates di Klagenfust in Austria che vuole celebrare i cinquecento anni dalla riforma luterana.
Durante la rappresentazione la scena più significativa è sicuramente quella finale, che ci proietta in uno scenario post apocalittico composto da un tappeto di pagine strappate che vengono lentamente raccolte, tramite bastoni, da uomini in tuta anti-radiazioni. È evidente il richiamo al film “2001 Odissea nello spazio” e alla sua atmosfera apocalittica, ma altrettanto chiara la simbologia luterana di critica al dogma, nelle pagine delle Sacre Scritture calpestate dall’uomo moderno.
La scenografia è coinvolgente, dà la giusta spazialità e profondità tramite l’utilizzo di quattro pannelli mobili, la sua contemporaneità attualizza il tema trattato. Le luci, ben studiate, come nella scena della “Mensa teologica” – dove sono presenti alcuni personaggi seduti ai tavoli – stigmatizzano i dialoghi. La potenza dello spettacolo è data in gran parte proprio da questi elementi scenici.
Gli attori riescono, tramite la loro espressività, a trasmettere le sensazioni dei personaggi, tuttavia le scene risultano lunghe e pesanti.
Cesare Lievi ha impiegato efficacemente la lingua tedesca, riflettendo il pensiero di Lutero che rifiutava il latino a favore di quest’ultima. La Bibbia tradotta dal latino ha favorito la diffusione della libera interpretazione delle idee in campo teologico, il sacerdozio universale si è così affermato. Tuttavia l’uso eccessivo del tedesco ha appesantito la rappresentazione, rendendola a volte poco comprensibile anche a causa dei sovrattitoli spesso mancanti e di difficile lettura grafica.
I vari livelli di lettura sono difficili da comprendere e da analizzare proprio perché, rimandando alla teoria del libero arbitrio, lo spettatore può interpretare a suo giudizio ciò che compare sul palcoscenico.
Il teatro deve essere aperto a tutti, ma per una comprensione profonda dell’opera è qui necessaria una conoscenza storica sulla riforma luterana che non è sempre alla portata del pubblico. Questo rappresenta una limitazione evidente.
Emerge uno spettacolo nebuloso, a tratti confuso, anche se colmo di possibili riflessioni e legato ad una bellissima messa in scena.
Rubrica di commento
I primi decenni del Cinquecento furono caratterizzati dalla nascita del protestantesimo ad opera del monaco tedesco agostiniano Martin Lutero. Questo periodo storico ha condizionato fortemente ogni aspetto dell’esistenza: la religione, la visione di Dio, il rapporto con l’entità suprema, l’interpretazione delle sacre scritture, il principio d’autorità e i dogmi imposti dalla chiesa. Se oggi abbiamo la libertà di scegliere lo dobbiamo al cambiamento portato da Lutero. Da “Il giorno di un Dio” emerge l’autonomia dell’uomo nel creare un rapporto personale con Dio, senza mediazioni, senza interventi superiori, considerati un tempo indispensabili e necessari, dovuto ad ud una maggiore fiducia nelle capacità umane portata dal protestantesimo. È in questo periodo che il credente inizia ad essere meno passivo nei confronti della propria religione. Un’altra tematica molto forte ed attuale riguarda le guerre di religione, spesso pretesto – allora come ora- di conflitti politico-economici. Viene messa in risalto l’incapacità dell’uomo di apprendere dai propri errori. Lo spettacolo è un continuo riferimento alla spiritualità vista come un viaggio profondo ed interiore, legata a messaggi forti, non sempre facili da comprendere ed interpretare. È una rappresentazione in chiave moderna e simbolica dell’uomo, destinato dal contesto storico e sociale a farsi condizionare, e tutta via desideroso di lottare per la propria libertà morale.
Classe IV C e IVN Liceo artistico F. Arcangeli di Bologna
La classe operaia va in paradiso

Recensione
“Operai… Operaie… Per voi la luce del sole oggi non splenderà…”
Luci abbaglianti, sirene assordanti, arie di musica classica suonate dal vivo, segmenti video dell’epoca, contribuiscono a costruire un ponte tra l’oggi e il passato del film.
Gli anni ’70: un’epoca lontana, avulsa dalla nostra realtà, anni in cui vengono raccontati la genesi e il contenuto del film, anni di lotte politiche, di rivendicazioni sindacali e di rivoluzioni familiari, anni di proteste attive e coinvolgenti. Gli anni ’00: un’epoca moderna, felice, forse edulcorata, anni in cui gli operai sembrano scomparsi, in cui la politica sembra appartenere solo alla televisione, in cui le proteste vengono filtrate dai social.
Il rapporto fra film e spettacolo, nella rappresentazione, è considerato sotto due aspetti: la genesi del film, con l’intervento dei personaggi che incarnano Petri e Pirro, e un feedback da parte degli spettatori che negli anni ’70 hanno visto il film nelle sale cinematografiche.
I nove attori che si presentano sul palco, riescono ad interpretare e differenziare i vari personaggi che caratterizzano le scene; personaggi di ogni tipo, appartenenti alla classe operaia, a quella dirigente, a quella studentesca. Le scene risultano molto dinamiche per i frequenti cambi di personaggi da parte degli attori e dei molteplici usi della voce.
La musica è un altro elemento fondamentale di regia, con una doppia funzione. Tramite le canzoni cantate in mezzo al pubblico, con l’aiuto solo di una chitarra, la musica di Fausto Amodei accentua l’aspetto di critica politica, proiettata in entrambe le società coinvolte nell’analisi; le melodie di violino e piano di Antonio Vivaldi, invece, contestualizzano la scena in un inverno reale e metaforico.
“Per la prima volta vedo la realtà di fatto…Questo film apre un nuovo campo di indagini, punta l’obiettivo su una nuova realtà non solo nella fabbrica ma anche fuori.” È l’affermazione con cui si accendono le luci in platea e che dà inizio a un dibattito realmente accaduto tra spettatori degli anni ’70 all’uscita del film nelle sale.
Queste parole svegliano lo spettatore e lo obbligano a rendersi conto che la realtà rappresentata dal film non è così estranea alla sua.
La complessa regia di Claudio Longhi, frutto di un intenso lavoro sui documenti, non ha semplicemente il fine di mettere in scena uno spettacolo “da vedere”, pensato per deliziare gli occhi del pubblico, ma vuole disturbarlo, scatenare una reazione, una riflessione. Questo era lo stesso scopo che Petri e Pirro si proponevano di raggiungere negli anni ‘70.
Le discussioni tra regista e sceneggiatore che condussero alla genesi del film sono presenti nello spettacolo e si alternano alla narrazione vera e propria.
“Se c’era, in questo momento, un film da fare, era ‘La classe operaia va in Paradiso’.”
Elio Petri sperava con la sua opera di fare aprire gli occhi, di colpire nel profondo il Partito Comunista, il suo partito. Il principale destinatario di questo film ebbe invece una reazione violenta: rifiutò questi personaggi grotteschi –il cronometrista, Lidia, Lulù- che non erano stati “santificati” come avrebbe voluto l’ideologia del partito.
Questo sentimento di negazione viene raccontato dagli spettatori del ’71 all’uscita del film nelle sale. Oggi la realtà del lavoro è mutata, in quanto l’operaio come Lulù Massa non esiste più, ma non è completamente diversa, dal momento che “come farà mai il mondo a cambiar se in fondo in fondo lo sfruttato sogna un giorno di sfruttar.”
Il rischio è continuare a non vedere e a etichettare certi temi come “datati”.
Rubrica di commento
“Quale sia il tuo destino, è più vantaggioso lavorare; distogli dai beni degli altri l’animo sconsiderato e al lavoro rivolgiti, pensa ai mezzi per vivere, così come io ti consiglio…”. Lo spettacolo inizia con questa citazione de “Le Opere i giorni” di Esiodo, che ben riassume l’idea intorno alla quale ruota la vita di Lulù: il nostro operaio si sente realizzato solo in quanto lavoratore, in quanto parte di un tutto del quale sente di essere un ingranaggio fondamentale. Anche oggi, a distanza di 50 anni, è difficile sentirsi individui completi senza il lavoro, fondamentale per sviluppare la nostra identità: ma in tutta questa frenesia, non rischiamo forse di perdere noi stessi? Non rischiamo di diventare noi stessi “la fabbrica”?
Proprio come Lulù, anche oggi il lavoratore deve lottare per affermare la propria individualità, i propri interessi, la propria diversità all’interno di una società sempre più unificata e globalizzata. Oggi come allora il lavoratore si trova fondamentalmente solo, privo di alcun punto di riferimento, costretto a navigare a vista in un mondo complesso e molto più grande di lui. Negli anni ’70 c’erano molte più istituzioni a cui affidarsi, che si credevano capaci di portare la rivoluzione all’interno della società, senza però vedere che la rivoluzione era già da tempo fallita. Sia i sindacati che il movimento studentesco per Lulù si rivelarono inutili, pieni di parole ma vuoti di azione, più concentrati a realizzare obiettivi utopistici che a porre veramente le basi per un cambiamento, difficile, ma necessario. E se oggi la politica pare lontana e aliena dai cittadini, forse è perché, in 50 anni di storia, nulla è davvero cambiato.
Liceo Scientifico Augusto Righi: Cecilia Biscarini, Rebecca Gironi, Maddalena Preziosi, Matilde Savorosi, Olga Serra, Gabriele Tosi
(coordinamento prof.ssa Matilde Maresca)
Va pensiero

Recensione
Un paesino anonimo dell’Emilia Romagna, nei primi anni Duemila. Un contesto volutamente indefinito, una storia che può estendersi a qualsiasi territorio, quella ideata e messa in scena da Marco Martinelli e dal Teatro delle Albe. Un palcoscenico con più elementi: un sipario rosso, un velatino e una pedana, che attira subito la nostra attenzione, leggermente decentrata verso sinistra. In questo luogo, ‘il patibolo’, i personaggi espongono loro stessi, qui emerge il lato corrotto e mafioso della loro essenza. Sulla destra è lasciato il posto a una gelateria, simbolo della lotta alla mafia. Infatti è emblematico che i proprietari non salgano mai sul patibolo, se non una volta sola, per denunciare ad alta voce, ‘in piazza’, quanto il loro paese sia corrotto e privo di giustizia. Ai lati del proscenio, due microfoni: punto di contatto tra i personaggi e il pubblico, momento in cui i protagonisti esprimono il loro pensiero, un modo di interagire con la loro coscienza.
“Mio padre sapeva farsi obbedire da tutti. Un capobranco. E io mi sentivo schiacciata.” È così che si sente la ‘Zarina’, sindaco di una piccola cittadina, quando è costretta a portare avanti un potere troppo grande per lei, se paragonato al ruolo autoritario esercitato precedentemente dal padre. Per dimostrare la sua autorità obbliga gli altri a farsi chiamare ‘il sindaco’ e non ‘la sindaca’. Dopo la morte del padre, perde il suo punto di riferimento, ritrovandosi sola, in balia di se stessa. Nonostante questa solitudine, però, lei rappresenta l’emblema del potere che si scontra con la sua personalità: durante il giorno è costretta ad indossare la maschera della carica che incarna, togliendola poi quando si trova da sola. Ermanna Montanari, elegantissima nei suoi abiti anni ‘50, sottolinea il cambiamento modulando l’uso della voce attraverso un tono fermo e autoritario quando è in pubblico, ma fragile ed insicuro quando è sola.
Olmo Tassinari, paesano la cui appartenenza al luogo è sottolineata da un forte accento emiliano, si presenta al fianco della Zarina, vecchia amica d’infanzia. La sua mentalità chiusa si delinea fin dalle prime battute: egli presenta al nuovo sindaco un grave problema, l’infestazione delle nutrie. Mentalità chiusa per via dell’incredulità e incapacità nel concepire la criminalità organizzata proprio a casa sua, in Emilia. Questo comportamento non è proprio solo del personaggio, ma è condiviso anche oggi da buona parte di noi, che non riconosciamo queste minacce e non pensiamo ci riguardino. Invece di aprire gli occhi e trovare il vero problema, Tassinari passa il tempo a preoccuparsi e lamentarsi dell’infestazione dei roditori. È possibile tuttavia individuare un parallelismo tra nutrie e mafiosi: entrambi “immigrati”, distruttori che agiscono indisturbati. La cosa peggiore è che l’ambiente ha permesso loro di mettere radici senza trovare ostacoli.
Il vigile urbano e i gelatai in esilio sono eroi quotidiani: attraverso gesti coraggiosi non si piegano alla violenza, tengono “la schiena dritta” e non sono servi di nessuno. Rosario e Maria, fuggiti da un sud criminale a un nord che credevano incontaminato, si trovano nella stessa situazione di partenza. Qui devono combattere da soli contro un avversario più grande di loro. Emerge una chiara critica contro l’autorità pubblica, impersonata dal sindaco, che mette in primo piano i propri interessi a discapito dei cittadini. Salvatore Caruso e Tonia Garante, grazie alla loro autentica parlata napoletana e all’immediatezza delle battute, sdrammatizzano la pesantezza degli argomenti. Il vigile Benedetti, interpretato da Alessandro Argnani, inizialmente sembra soltanto adempiere al suo ruolo di vigile, facendo rispettare la legge, in realtà sacrifica la sua vita in nome di ideali maggiori: la morale e la giustizia. Questo emerge dai suoi continui dialoghi con il pubblico, improntati ad un tono pacato e sincero che ci coinvolge.
Infine il coro, che si sviluppa in due modi differenti. Sullo sfondo è presente un vero e proprio coro, il Coro lirico Alessandro Bonci di Cesena, che accompagna la storia durante tutto lo spettacolo. Nel corso della vicenda invece in alcuni momenti i personaggi stessi tengono un discorso all’unisono, per attirare l’attenzione del pubblico sui temi chiave. Alla fine dello spettacolo i due cori si fondono per intonare “Va Pensiero”. La fusione non si limita a unire i cantanti e gli attori, ma mira anche a chiamare all’azione lo spettatore, esortandolo a liberarsi dalle schiavitù.
Rubrica
La realtà non è bianca o nera. Una storia è fatta di personaggi ed eventi molto più sfumati di quello che sembrano. Certi sono più interessanti di altri.
Chi ha scatenato le nostre riflessioni in “Va Pensiero”? Un vigile di provincia? Un uomo che si alza ogni mattina, motivato dalla voglia di tutelare le posizioni altrui in nome della legge. Non è un eroe, non pretende ricompense; per lui il senso del dovere supera ogni conguaglio in denaro.
La ‘Zarina’? Sindaco non per scelta, ma per nascita, lanciata nella tormenta del potere, ma senza una bussola. Donna di ferro, apparentemente inossidabile , che mostra sul ‘patibolo’ la propria debolezza. Mette il proprio interesse davanti a quello della sua cittadinanza, cedendo alla tentazione.
È facile distinguere il bianco dal nero in questa storia, dividendo i personaggi tra buoni e cattivi. Ma non siamo qui per dare un giudizio o un insegnamento morale. Siamo qui per discutere delle riflessioni che questo spettacolo genera. Il personaggio del vigile, per quanto degno della nostra ammirazione e rispetto, rappresenta un soggetto meno dinamico rispetto a quello della Zarina. Il dualismo della sua personalità spazia da atti deplorevoli a profondi sensi di colpa, rappresentati dall’attrice con dei conati di vomito. Non è una personalità morale, ma è sicuramente interessante, in tutte le sue sfaccettature e nei monologhi nei quali fa emergere il proprio conflitto interiore. Parafrasando Oscar Wilde “ non esistono personaggi morali o immorali, ma affascinanti e non”.
Classe VF Liceo Scientifico Augusto Righi
Federica Baraldi, Lorenzo Boaretto, Arianna Bonfiglioli, Elena Bregoli, Giuditta Calzati, Maria Giulia Camillo, Claudia Chinni, Manuel Franceschini, Anna Giordano, Lorenzo Grossi, Erica Mayer, Elisabetta Montani, Vittorio Olivi, Lorenzo Pasquali, Alessandro Pinzuti, Alessio Prosperi, Riccardo Rambaldi, Irene Ramponi, Edoardo Rosetti, Elena Rota, Michael Saruggia, Roberto Tabaroni, Alessandra Zambonelli, Susanna Zanni
(coordinamento prof. ssa Matilde Maresca)
Li buffoni

Classe IIIG – corso DOC Liceo Laura Bassi Bologna
(coordinamento prof.ssa Rossana Cappucci)
La Gioia

Recensione
Il giorno 1° marzo al teatro l’Arena del Sole abbiamo assistito alla rappresentazione teatrale di uno spettacolo di Pippo Delbono, La Gioia. In alcune tappe di questo spettacolo gli spettatori sono anch’essi protagonisti.
Questo è possibile perché Pippo Delbono non si limita a rappresentare lo spettacolo solamente sul palco, ma anche in platea, vicino al pubblico, intervenendo come autore o lettore e facendo sentire la sua voce registrata che genera un’atmosfera coinvolgente.
Lo spettacolo si apre con il brano di Bobby McFerrin, Don’t worry, be happy, mentre il primo attore entra più volte in scena innaffiando dei fiori che via via crescono e aumentano. Successivamente Pippo scende dal palco e, in modo quasi liberatorio, urla: ”Vai Gianluca!”. Subito entra un’improbabile Loretta Goggi che canta a tutto volume Maledetta primavera. Scopriamo poi da Pippo l’identità e la storia di Gianluca.
Cambia la scenografia, composta da barchette posizionate sul palco, che si immaginano muoversi alla melodia di Moonlight di Beethoven. E in mezzo a queste Pippo vaga, mano nella mano, con un personaggio fondamentale nelle sue rappresentazioni, ma soprattutto nella sua vita: Bobò.
Nel finale coesistono entrambi gli stati d’animo: gioia e dolore, rispettivamente rappresentati dalla musica e dalla voce di Pippo.
Pippo Delbono mette in scena quella che sembra essere una sfilata di personaggi ambigui, terrificanti e strani. Che rappresentano le varie tipologie della paura ma anche dell’orrore, dell’inquietudine. Gli attori hanno un ruolo fondamentale nel rappresentare i vari stati d’animo di Pippo.
La commistione di luci stroboscopiche, i costumi che evocano alcune tra le più comuni fobie, come la veste gotica indossata da una donna dalle sembianze spettrali, suscitano un senso di inquietudine, quasi di paura. I personaggi, camminando verso la platea, con addosso abiti scuri, a malapena distinguibili nell’oscurità del teatro – dove le luci vengono spesso abbassate come se l’arena fosse avvolta da un velo nero di tristezza – mettono quasi in soggezione il pubblico che avverte quasi a pelle la loro vicinanza.
La gioia non è un momento, la gioia è un cammino. Questo cammino è caratterizzato da un susseguirsi di stati d’animo che Delbono riesce a interpretare in modo quasi naturale e spontaneo nel suo spettacolo, ad averne piena consapevolezza.
Ma essere consapevoli può talvolta essere una debolezza e diventare un tormento che Delbono esprime urlando, dando voce ai demoni che si annidano dentro la sua testa.
La gioia non è un sentimento facile da capire e da raggiungere poiché solo dopo un periodo di buio si può arrivare alla luce. Ne è una testimonianza Bobò, la cui vita è stata un cammino difficile per arrivare alla gioia. La sua presenza è un elemento determinante per esprimere ciò che è inesprimibile, dando luce a chi è nel dubbio. Il piccolo diavoletto suscita anche un senso di innocenza e tenerezza, soprattutto quando pronuncia il suo discorso.
Ogni cosa della rappresentazione porta a pensare che ci sia gioia nel dolore e dolore nella gioia, che essi si integrino come lo Yin e lo Yang,. Infatti, senza sofferenza, la felicità non sarebbe così tanto attesa e ricercata. Durante lo spettacolo le scene di gioia e quelle di dolore si alternano continuamente, ma solo nel finale le due emozioni opposte coesistono in armonia, l’una essenziale all’altra.
In conclusione è pensiero comune che la vera gioia risieda nel viaggio per raggiungerla.
Rubrica di commento
“La parola gioia fa paura, fa paura perché è abusata, strumentalizzata e banalizzata dall’illusione di essere felici”.
Al giorno d’oggi associamo la gioia ad un normale senso di felicità generale. Lo spettacolo invece esprime la gioia come un sentimento più profondo, non così scontato, che passa anche attraverso il dolore, la paura, la tristezza, la follia e il senso di solitudine.
Ma che cos’è realmente la gioia?
La gioia è quel sentimento di completezza che ti pervade nel profondo. La gioia ci permette di uscire dalle nostre gabbie, sfuggire alle preoccupazioni, rendendoci liberi e più leggeri.
Anche le cose tristi passano, anche i dolori e la disperazione impallidiscono, perdono la loro profondità e la loro consistenza, fin che viene un momento in cui non ci si può più ricordare cos’era stato a far tanto male. È la gioia infatti che crea spazio dentro di noi.
Ha un potere tale da poter derivare anche dalle più piccole cose.
Nello spettacolo, per arrivare alla gioia, si affrontano le diverse emozioni negative, che sono correlate ad essa. “Bisogna intraprendere un cammino verso la parte più profonda dell’essere umano per apprendere l’ideale di gioia, la quale si nasconde dove ci celano i dolori più intensi”.
Forse proprio per questo motivo la gioia viene banalizzata, perché viviamo in un mondo di finzioni ed apparenze, dove le persone non dicono mai ciò che si cela dietro alle loro parole e alle loro azioni, sottovalutando la pienezza e la profondità dei sentimenti.
Classe I P Liceo Scientifico Augusto Righi
(coordinamento prof.ssa Paola Ricciotto)
Il nome dela rosa

Recensione
Dopo il film diretto nel 1986 da Jean-Jacques Annaud, questa pièce è la prima trasposizione teatrale dell’omonimo best seller di Umberto Eco. L’anziano Adso ricorda gli avvenimenti accaduti nell’anno 1327 in un’abbazia benedettina famosa per la sua ricca biblioteca. A quel tempo il giovane Adso aveva seguito il suo maestro, Guglielmo da Baskerville, frate francescano dalle spiccate capacità deduttive, in una missione segreta che li porta in quel monastero, ospiti dell’abate. Quest’ultimo chiede privatamentea Guglielmo di indagare sulla morte misteriosa di un confratello, deceduto poco prima del loro arrivo.
Quando, poco dopo, un altro confratello viene trovato senza vita, i frati e Adso stesso credono che i decessi siano opera del demonio, mentre Guglielmo è convinto che dietro a questi avvenimenti ci siano “mani umane”. Dopo una visita allo scriptorium, dove ha luogo un’accesa discussione sul riso tra Guglielmo e il venerando e cieco frate Jorge, si procede con le indagini e si scopre che i delitti sono legati ad un segreto custodito nella biblioteca, la quale ogni sera viene chiusa dall’interno dal bibliotecario, fra Malachia. Guglielmo capisce che il testo a cui l’ultimo monaco ucciso stava lavorando contiene un enigma da decifrare che porta ad un libro misterioso.
In seguito alla morte del terzo confratello si nota un elemento comune ai tre cadaveri, che hanno tutti le dita della mano e la lingua tinte di colore scuro.
In abbazia entra quindi in scena Bernardo Gui, un inquisitore domenicano, il quale, dopo aver estorto con la tortura l’ammissione delle loro colpe ad una giovane donna che si è precedentemente intrufolata nel monastero e all’uomo con cui essa ha giaciuto, li condanna al rogo.
Il frate erborista, il quale ha confidato a Guglielmo di aver rinvenuto nel proprio laboratorio il libro sospetto, viene trovato morto di un colpo alla testa; e l’inquisitore, sempre ricorrendo alla tortura, condanna il cellario come responsabile dei precedenti delitti e in quanto eretico dolciniano.
Durante un rito religioso, però, muore di colpo anche Malachia, che presenta le stesse macchie nere trovate sugli altri cadaveri. Nel monastero si è sempre più convinti che le morti siano segni dell’imminente avvento dell’Anticristo e dell’apocalisse, mentre Guglielmo, fondandosi sull’analisi dei dati in suo possesso, rimane fermo nella sua posizione, ovvero che le uccisioni siano opera di esseri umani. Infastidito dal suo ostinato razionalismo, l’abate decide di cacciare maestro e novizio dall’abbazia, ma i due, sempre più desiderosi di scoprire la verità, restano all’interno del monastero e si addentrano nella biblioteca.
In questo luogo Adso e la sua guida risolvono l’enigma: il colpevole è Jorge, il quale, dopo aver confessato di aver cosparso di veleno i bordi del volume, il secondo libro della Poetica di Aristotele, da tutti ritenuto perduto, per impedirne la consultazione, provoca un incendio che distrugge la biblioteca e i suoi preziosi volumi, a cominciare da quel libro aristotelico dedicato alla commedia, che, secondo l’austero Jorge, avrebbe potuto con il riso destabilizzare e dissacrare tutti i valori più sacri e venerabili, carnevalescamente ribaltandoli. Ecco spiegata la perdita di tanti capolavori della letteratura antica e medioevale.
L’ambiente interno del monastero è riprodotto molto realisticamente e rispecchia lo spirito cupo e macabro della vicenda; gli effetti sonori e gli oggetti di scena conferiscono allo spettacolo credibilità e rendono perfettamente lo stato d’animo dei personaggi. Il regista Leo Muscato si è attenuto fedelmente alla vicenda, tra il poliziesco, il semiotico e lo storico, raccontata da Eco, e precedentemente adattata per il teatro da Stefano Massini, solo inevitabilmente ed opportunamente riducendone in modo drastico le lunghe digressioni filosofiche, inadatte alla rappresentazione scenica. Quattro salve di applausi hanno mostrato l’apprezzamento del pubblico per uno spettacolo la cui visione raccomandiamo caldamente a chi desideri avvicinare un’opera di indubbio spessore culturale, presentata in modo accessibile anche per un pubblico giovane.
Rubrica di commento
Due ore e mezza di noia, una storia pesante e lontana dalla nostra realtà: questo temevamo sarebbe stato Il nome della rosa. Inaspettatamente, le cose non sono affatto andate così. Infatti lo spettacolo si è rivelato accattivante e coinvolgente, grazie all’ambientazione indovinata e all’interpretazione degli attori, perfettamente calati nella loro parte. Inoltre, la storia è tutt’altro che circoscritta all’epoca medioevale, poiché affronta tematiche politiche, sociali e culturali senza tempo.
Prima fra tutte, la lussuria e l’amore carnale, condannati come peccati capitali dalla Chiesa, ma a cui i frati del convento benedettino in cui è ambientata la vicenda non sanno rinunciare. Il che sembra puntare il dito contro certa ipocrisia della Chiesa al riguardo e solleva un problema ancora attuale: è veramente giusto l’obbligo del celibato ecclesiastico?
Universalmente moderno è poi il tema della censura di libri contenenti novità ed idee considerate pericolose in qualsivoglia ambito, dall’analisi della società alla scienza, dalla letteratura alla religione. Se nella pièce tratta dall’omonimo romanzo di Umberto Eco tutto ruota intorno al perduto secondo libro della Poetica di Aristotele, dedicato alla commedia, e alla forza carnevalescamente dissacratrice del riso, la censura vige ancora oggi in molti regimi dittatoriali, che mantengono la popolazione nell’ignoranza e all’oscuro del dibattito culturale, per timore che cittadini istruiti possano prendere coscienza dell’oppressione subìta e si ribellino contro i loro aguzzini.
Ma probabilmente la tematica più universale presente nel Nome della Rosa è il problema della ricerca della verità. Infatti, gli uomini nel corso del tempo hanno spesso individuato in determinate categorie sociali dei capri espiatori su cui far ricadere le colpe dei problemi che li affliggevano. Allo stesso modo in cui nello spettacolo si condannano gli eretici e le streghe (o nei Promessi Sposi si attribuisce la peste a presunti untori), così in tempi più moderni la diffidenza e la persecuzione si sono esercitate nei confronti prima degli ebrei e ora degli immigrati. Questo è a nostro avviso lo spiraglio essenziale che Umberto Eco apre tra la sua storia (ottimamente adattata al teatro da Stefano Massini e Leo Muscato) e il mondo reale di ieri e di oggi.
Classe IIIP Liceo scientifico Enrico Fermi
Giovanni Cavazza, Lorenzo Fabbri, Chiara Isacco, Lucia Lovallo, Martina Sgarzi, Giulia Zheng
Elena Bacci, Simone Barbera, Clarissa Grandi, Eleonora Pini, Greta Scapoli, Simone Trambaiolo
(coordinamento prof. Ivan Montebugnoli)
Il giardino dei ciliegi. Trent'anni di felicità in comodato d'uso

Recensione
Sabato 17 marzo ci siamo recati presso il teatro l’Arena del sole, per assistere allo spettacolo “Il giardino dei ciliegi”, trent’anni di felicità in comodato d’uso”, rielaborazione in chiave moderna del classico di Čechov. Entrati in sala, non ci siamo imbattuti nel tipico contesto teatrale con sipario chiuso, bensì abbiamo trovato una scena aperta e gli attori, che, seduti sul palco, attendevano l’arrivo del pubblico. Siamo rimasti incuriositi da questa atmosfera informale e surreale, tanto da non capire come lo spettacolo potesse prendere forma.
Il palco è occupato da vari mobili, appartenenti alla famiglia Bianchi, che evidenziano il contrasto tra borghesia e proletariato e si può anche notare la differenza tra la Russia dell’Ottocento e l’Italia di oggi, in particolare la città di Bologna. Questa tematica è riscontrabile soprattutto nella scena in cui Lodovico stappa lo champagne, simbolo di ricchezza, e nella presenza dei bicchieri di plastica, tipici dei ceti più umili. La presenza di un duplice piano spazio-temporale si può anche dedurre dalle diverse incongruenze che si trovano sul palcoscenico, come ad esempio le valigie, che ricordano il dramma di Čechov, e le gabbie, che al contrario narrano la storia dei coniugi Bianchi. Infatti gli attori hanno un doppio ruolo, poiché vi è l’intreccio di due storie, quella di Ljuba e Gaiev e di Annalisa e Giuliano. A seconda della scena rappresentata vengono utilizzati costumi differenti: le pellicce per indicare il contesto cronologico dell’opera originale, mentre gli abiti moderni per raccontare la vita dei Bianchi.
La scena si apre con l’entrata di tre personaggi: Nicola Borghesi, Paola Aiello e Lodovico Guenzi, che ci accolgono seduti sul palco, illuminati dalla luce riflessa su uno specchio.
La disposizione della platea favorisce l’interazione e il rapporto empatico tra attori e pubblico, quest’ultimo è chiamato a partecipare attivamente alla vicenda, rivestendo il ruolo di comparsa.
L’utilizzo della luce è funzionale alla trama, infatti nel teatro si avverte un senso di tristezza, precarietà e dismissione, che però non inibisce la comicità suscitata dagli attori.
Gli attori che partecipano a quest’opera sono cinque, tra cui due non professionisti. Questi ultimi sono Annalisa e Giuliano Bianchi, una coppia bolognese, che ha abitato in una casa colonica di periferia concessa in comodato d’uso dal comune per trent’anni, convivendo con animali esotici e talvolta pericolosi. I coniugi sono stati scelti perché sono le proiezioni nel presente di Ljuba e Gaiev, protagonisti de “Il giardino dei ciliegi” di Čechov, avendo vissuto simili esperienze nella loro vita. I Bianchi, pur non essendo attori professionisti, riescono a valorizzare il testo a modo loro, incarnandolo per via del loro vissuto e riescono a far trasparire le proprie emozioni, la nostalgia e lo strazio, raccontando la loro vicenda in prima persona.
Paola Aiello, collaboratrice del regista, e Nicola Borghesi, nonostante siano professionisti, si mettono in secondo piano facendo risaltare i Bianchi, mentre Lodovico Guenzi anima la scena.
Borghesi ha una recitazione fluida, spontanea e una voce stentorea che emerge nel suo monologo. Lodovico, che interpreta Lopachin, un borghese arricchito, compra “Il giardino dei ciliegi” per riscattarsi e rivendicare lo stato di schiavitù dei genitori in quel terreno, facendo un monologo nel quale contrappone la sua felicità per il successo dell’acquisto e la tristezza dovuta al legame emotivo con Ljuba.
La recitazione è la capacità di costruire un’emozione che può suscitare o meno l’animo dello spettatore.
Finito lo spettacolo ci siamo posti molte domande diverse fra loro, ma fra tutte quella che ci è sembrata più rappresentativa era: chi realmente esce sconfitto e chi vincitore dall’opera? La ricchezza interiore o quella materiale? Chi ricerca una vera felicità e chi una effimera? Questo spettacolo lascia molte questioni aperte e lo spettatore è invitato a darsi una risposta mettendosi in gioco e mettendo in discussione le proprie certezze.
Rubrica di commento
Cos’è giusto e cos’è sbagliato? Cosa ci rende felici? Quanto le nostre idee, le nostre scelte e il nostro stile di vita influenzano il nostro modo di vedere la realtà o ci rinchiudono, limitando la nostra propensione al cambiamento? Queste sono le domande che ci ha posto indirettamente lo spettacolo “Il giardino dei ciliegi- Trent’anni di felicità in comodato d’uso”, caratterizzato da evidenti contrasti e dubbi.
Il confine tra giusto e sbagliato è sottile e dipende molto dal nostro modo di pensare, condizionato, a sua volta, dall’ambiente in cui viviamo. Infatti può sembrare ingiusto ai coniugi Bianchi il fatto di essere stati sgomberati dalla “loro” casa, che aveva rappresentato per ben trent’anni la felicità , la stabilità e la pace, poiché nel loro piccolo riuscivano a completarsi a vicenda. Dall’altro lato è anche vero che erano coscienti fin dall’inizio che prima o poi sarebbe accaduto di lasciare quello che per loro costituiva un “porto” sicuro. È una storia di tenace speranza che ci tocca nel profondo. Infatti non ci sembra possibile, dall’alto dei nostri pomeriggi passati nei bar chic del centro e delle nostre passeggiate nelle vie dello shopping, che una famiglia quasi al limite della credibilità possa rifugiarsi in una sorta di realtà parallela in cui tutto sembra perfetto anche quando non lo è. Ci hanno molto colpito le parole di Giuliano quando afferma che finché era vissuto in quella casa di via Fantoni , che ormai considerava sua, con la sua famiglia allargata, non c’era una mattina in cui non si svegliasse felice, a differenza invece dell’ attore/regista, Nicola, che era sempre stressato.
Secondo il nostro parere, nella rappresentazione è inoltre evidenziato un altro tema, ossia la generalizzazione del male e del bene. Abbiamo trovato molto autentica l’improvvisazione di Lodo, il quale durante un toccante monologo, chiede ad Annalisa perché nell’immaginario collettivo l’idea del male sia sempre associata a ciò che appare grande, lussuoso e appariscente , mentre al contrario il concetto di bene a ciò che è piccolo, modesto e semplice. Questo assioma, come dice egli stesso, non è così inconfutabile e assoluto, ma spesso tendiamo a essere condizionati da alcune etichette che ci impone la società. Le dice poi di liberarsi dalle sue “zavorre” mentali, di “rinascere”, abbandonando quelle convinzioni e quella visione del mondo che la imprigionavano in una gabbia che si era costruita con le scelte radicali che aveva fatto e che le avevano precluso il resto. Questa tematica si ricollega ad un discorso dello stesso Lodo/Lopachin che racconta di aver fatto la cosa più giusta della sua vita, e di essersi sentito quasi un eroe, quando si era svegliato alle cinque di mattina per accompagnare Giuliano in quella casa, ormai tetra e buia, solo per rubare qualche mobile e i grappoli d’uva del giardino. Facendo ciò, Lodo aveva però la consapevolezza di non essere uguale al signor Bianchi, bastava solo guardare come il primo cogliesse i grappoli più maturi e belli, secondo un criterio che molto spesso utilizziamo involontariamente, poiché cresciuti in una società che ci educa alla ricerca del bello e della perfezione, mentre l’altro non faceva alcuna selezione. Si sentiva anche un po’ ipocrita, perché mentre i Bianchi erano stati sgomberati per la costruzione di un nuovo centro commerciale, lui era proprio lì, nello stesso centro commerciale a passeggiare tra gli espositori; perché, per quanto si fosse sentito un eroe, restava pur sempre un borghese abituato a idee e ad uno stile di vita diversi. Infatti, come dice anche Lopachin nel dramma di Čechov: “Non bisogna mai scordarsi di quello che si è.”
Classe II D Liceo Scientifico Enrico Fermi
(coordinamento prof.ssa Angela Nasuti)
Otello

Recensione
Il giorno 22 marzo siamo andati al teatro Arena del Sole dove abbiamo partecipato all’Otello di William Shakespeare. Lo spettacolo è iniziato alle ore 21 sotto la regia di Elio de Capitani e Lisa Frelazzo Natoli. La traduzione originale del testo è stata curata da Ferdinando Bruni e la messa in scena è della Compagnia teatrale dell’Elfo.
Una volta preso posto si sono spente le luci e all’improvviso dalla platea sono usciti Iago e Roderigo urlandosi contro. E poco dopo la loro discussione si è aperto il sipario svelando un telo d’oro che rappresentava la prima scena nella casa di Brabanzio.
I costumi sono semplici e allo stesso tempo adeguati al ruolo di ogni personaggio.
All’inizio non ci sono né effetti sonori né musiche, fino alla scena della tempesta dove viene sollevato il telo di cellophane con un sottofondo musicale. Il telo rimarrà in scena fino alla fine, trasformandosi di volta in volta.
All’interno di un’ambientazione molto semplice alcuni elementi colpiscono più di altri. Per esempio gli attori si posizionano nello spazio in modo molto preciso e monumentale disegnando geometrie in scena e valorizzando l’attore che in quel momento recita.
Gli attori hanno una cifra recitativa precisa, il loro linguaggio è semplice, ma non del tutto quotidiano.
Luci e musiche accompagnano gli spettatori a comprendere le emozioni che ci vogliono trasmettere. L’uso delle luci che cambiavano a seconda del succedersi delle scene, aiutava l’immaginazione dello spettatore a figurarsi le diverse ambientazioni dello spettacolo (palazzo, mare in tempesta, camera da letto…).
Anche l’alternarsi della musica, dal vivo o registrata, contribuiva al procedere della narrazione sottolineandone le sfumature emotive.
Secondo noi Shakespeare tratta argomenti presenti alla sua epoca ma che purtroppo coesistono anche oggi nella società attuale. Come per esempio la gelosia, l’ira, l’invidia, la rabbia che sono frequenti nella giovane età dove il sentimento d’amore è ancora acerbo, ed è più esposto a questo tipo di emozioni pericolose e malsane. Anche per questo lo spettacolo ci ha coinvolto ponendoci alcune domande che a distanza di cinquecento anni continuano a interrogare l’essere umano e che noi poniamo a voi lettori: perché si arriva ad uccidere per gelosia? Cosa porta ad avere mancanza di fiducia nella persona che si ama? Perché non credi alle parole di chi ami? Perché riesce la gelosia a logorarci dentro? Da cosa capiamo se una cosa è vera o falsa? Perché si ripetono queste situazioni insane? Perché per raggiungere il potere siamo disposti a tutto anche sacrificando la vita di chi amiamo e degli altri?
Queste sono le domande che lo spettacolo ci ha suscitato e che ora come allora ancora aspettano una risposta.
Rubrica di commento
L’Otello ha acceso una ricca discussione fra noi sui tanti temi della tragedia.
Ci siamo focalizzati soprattutto sulla scelta del protagonista principale, ovvero Otello. Perché il regista ha scelto un attore bianco anziché un attore nero?
Secondo alcuni hanno dato la parte di Otello ad un attore bianco sia per fare immedesimare il pubblico, sia per spingere gli spettatori a ragionare su questa scelta.
La discussione ci ha portato a pensare che questa preferenza di regia volesse mostrare al pubblico che la diversità non è per forza manifesta, come il colore della pelle, ma che esiste anche una diversità interna ad ognuno di noi.
Secondo altri, invece avrebbe avuto più effetto un Otello nero, perché una persona di colore nell’atto di baciare una ragazza bianca e bella e giovane crea più attenzione in quanto abbatte un pregiudizio.
Al di là delle ragioni che hanno spinto il regista alla scelta, pensiamo che un Otello nero avrebbe avuto un impatto maggiore sul pubblico e avrebbe reso più manifesta la complessa relazione fra persone che appartengono a mondi diversi.
Classe III Operatore del Punto Vendita del Ciofs/Fp di Bologna
(coordinamento prof. Davide Pace e Federico Colombarini)
Il sindaco del Rione Sanità

Recensione
Niente di nuovo, niente di nuovo: è attraverso questi versi che Mario Martone ci proietta in una Napoli moderna, ma fondamentalmente non diversa da quella di Eduardo De Filippo.
Il sindaco del Rione Sanità, inscenato per la prima volta nel 1960, viene oggi presentato sotto una luce nuova e più attuale, dalla compagnia teatrale NEST, attori strappati dalla strada e da una realtà criminale nella periferia napoletana.
Un giovane rapper, Ralph P, due rottweiler maestosi e intimidatori, unica luce quella del display di un cellulare: è questa l’antifona della rappresentazione.
La scenografia curata da Carmine Guarino, nella sua semplicità, si adatta ai diversi contesti e risulta quindi efficace proprio perché essenziale. Il mobilio delle abitazioni, pur essendo minimalista, evidenzia lo sfarzo di chi vive nella camorra attraverso l’introduzione di dettagli quali decori in oro o lussuosi lampadari.
Le luci di Cesare Accetta, variando di intensità, focalizzano l’attenzione dello spettatore e valorizzano la scenografia.
Ha sicuramente un ruolo di rilevanza l’abbigliamento dei vari attori, sebbene rimanga invariato nel corso della rappresentazione per la maggior parte degli interpreti. E’ visibile un accostamento tra i colori della scenografia e degli abiti: l’abbigliamento iniziale del protagonista (Francesco Di Leva), sulle tonalità del nero, è perfettamente abbinato con lo sfondo del primo atto; allo stesso modo la giovane figlia di Barracano (Morena Di Leva) indossa un abito sfarzoso che riprende l’oro predominante nella scenografia del terzo atto. Ugualmente rilevante è la presenza di una cravatta di colore blu elettrico indossata dal protagonista: essendo questo l’unico indumento di colore sgargiante, l’attenzione cade in modo diretto su Barracano.
Lo spettacolo è interamente in dialetto napoletano. Questo, a nostro parere, ha reso la comprensione della vicenda piuttosto impegnativa; tale disagio, però, viene compensato dalla straordinaria capacità di espressione degli attori, favorita da una accentuata ed evidente gestualità che rende la rappresentazione estremamente realistica.
Il Barracano di Martone è un personaggio fisico e per questo, essendo giovane e nel pieno delle proprie forze, si approccia agli altri in maniera aggressiva, ottenendo così il loro rispetto; diversamente il Barracano di De Filippo è un uomo anziano che si serve della sua già nota fama di “sindaco del Rione Sanità”, senza bisogno di affermare la sua autorità con un atteggiamento veemente.
Mario Martone,caratterizza il personaggio non più come simbolo di una criminalità galante in decadenza, ma come un giovane e deciso capo camorrista dei giorni nostri. Mentre il Don Antonio di De Filippo porta con sé i segni interiori della vecchiaia, i segni del nuovo boss sono causati dalle botte date e prese nel corso del suo operato nel Rione. La veemenza e l’utilizzo della forza fisica in certe scene rappresentano una malavita più giovane e brutale.
Anche le scelte musicali sono risultate efficaci. All’inizio il rapper Ralph P con la sua canzone Niente di Nuovo porta sul palco dell’Arena del Sole la periferia da cui provengono gli attori del NEST, facendo calare lo spettatore nell’ambiente della Napoli moderna, musicalmente molto orientata verso il rap. Le basi hip-hop degli intermezzi sono ritmicamente originali e il genere musicale si sposa con l’abbigliamento e il comportamento dei personaggi. Inoltre l’accostamento di una dolce canzone folk a una scena violenta, dà un’idea di ordinarietà e abitudine alla giustizia fai da te.
Il finale di Martone, significativamente diverso da quello di Eduardo, non risulta nè banale nè esagerato, ma improvviso, toccante e insieme silenzioso.
Nel complesso lo spettacolo lascia soddisfatto il pubblico, ammaliato dalla bravura trascinante degli attori.
Rubrica di commento
Niente ‘e nuovo
Attraverso la sua canzone, Ralph P vuole sottolineare come la società odierna sia in realtà simile a quella descritta da Eduardo De Filippo ne Il sindaco del Rione Sanità nonostante il grande distacco temporale. Non è infatti cambiato nulla da quando nel 1960 i comuni cittadini, definiti ignoranti dallo stesso Antonio Barracano, non potendo affidarsi alla legge di cui si avvalevano solo i più furbi, si rifugiavano nell’omertà.
Comparando l’opera di De Filippo con la rivisitazione proposta da Martone, saltano all’occhio le differenze tra i finali dei due spettacoli: mentre in quello originale Fabio Della Ragione, dottore di Barracano, rivela tramite il referto medico il segreto di ‘O Cuozzo, testimone dell’accoltellamento di Antonio, in quello di Martone la sua omertà rimane impunita.
Purtroppo, persino al giorno d’oggi questo comportamento reticente è talmente diffuso che possiamo riscontrarlo anche nella nostra quotidianità: a casa, a scuola, al lavoro…
Chi non ha mai visto qualcuno non fare il biglietto dell’autobus?
Chi non ha mai chiuso un occhio per uno scontrino non fatto?
Facciamo ormai troppo spesso finta di non vedere queste piccole mancanze che per questo motivo tutti commettono.
La realtà che ci racconta Eduardo De Filippo è quella della vita di tutti i giorni, in particolare in alcuni quartieri di Napoli: siccome i cittadini non possono affidarsi alla legge, in quanto corruttibile, preferiscono riporre la loro fiducia in individui, come Barracano, che agiscono al di fuori della legge.
‘’Chi tiene i santi va in paradiso, chi non li tiene…”
“Va all’Inferno!”
“…No, viene da me”
Classe II L Liceo Fermi di Bologna
(coordinamento prof.ssa Carla Donati)
Le avventure di Numero Primo

Recensione
Le avventure di Numero Primo è l’ultimo spettacolo di Marco Paolini, scritto assieme a Gianfranco Bettin e ambientato tra Mestre e Venezia in un futuro non troppo lontano, ma che ha conosciuto un rivoluzionario progresso tecnologico. Paolini, che già ci aveva parlato di scienza nel 2014 raccontandoci di Galileo, non trascura le tematiche sociali sempre presenti nei suoi spettacoli, ma abbandona ora le storie passate per cimentarsi con una favola sul futuro, sebbene più che mai vicina al presente. Egli storce il naso quando il mondo che descrive viene etichettato come distopico, eppure lo spettatore fatica ad accettare che, come avviene nello spettacolo, una capra realizzata con una stampante 3D possa un giorno essere davvero recapitata da un corriere di Amazon in meno di quarantacinque minuti. La neve artificiale del ‘Polo (Nord) Marghera’, le mele ‘motivazionali’ in vendita nei supermercati a dare la carica giusta per la giornata, i gabbiani-drone dal becco rosso (per distinguerli da quelli veri) sono tutti artifici per dipingere un mondo che, pur proiettato nel futuro, punge nel vivo gli spettatori con la sua attualissima plausibilità.
A cinquemila giorni dal presente, il fotografo di guerra Ettore Achille si ritrova padre naturale per atto notarile, senza atto sessuale: una formula ossimorica che è tutto un programma. Cedendo alla richiesta di Echné, una donna conosciuta in rete di cui si è innamorato, Ettore acconsente a diventare padre di Numero Primo, un bambino di sei anni che si scopre essere un’intelligenza artificiale provvista del corpo e dell’animo di un normale essere umano. Raccontando le peripezie della strana famiglia monoparentale, Paolini diverte e affascina pur seminando nella storia i tratti di una società multiculturale e difficile e affrontando en passant i temi attualissimi della povertà e dell’immigrazione.
Paolini adotta anche in questa occasione la tecnica del monologo, alternandosi nei ruoli del narratore e del personaggio, e aggiungendo tra una scena e l’altra piccoli intervalli musicali, prolettici al finale della storia. Non importa che il palco sia spoglio, e che soltanto lo sfondo sia vagamente evocativo della storia in corso. Lo spettatore è lì, con Ettore e con Numero (e con la capra del bambino, naturalmente, poiché i due sono inseparabili) e non può fare a meno di sentirsi coinvolto, anch’esso genitore obtorto collo di quel bambino di sei anni per cui tutto ‘è bello’.
Numero Primo è una provocazione, è un unicum, è il primo esemplare di qualcosa che Ettore Achille non può nemmeno capire a fondo. Anche il nome che il bambino si sceglie, a dire il vero, non è un vero nome, eppure Numero si comporta da umano, nonostante la sua origine artificiale. Addirittura, il novello Pinocchio è in sintonia con la natura quasi più dei ‘bambini veri’, che imparano da lui senza rendersene conto. Ettore capisce presto che Numero anima gli altri e guarda il mondo con occhi diversi. Come le formiche hanno un loro linguaggio, così il cervello di Numero Primo connette le sinapsi a modo suo, in linea con la sua natura ibrida, cibernetica e umana. Numero Primo è il ponte che collega l’uomo alla tecnologia, la quale, anche se sembra avere uno sviluppo autonomo e al di là del nostro controllo, in realtà sarà parte della ‘natura’ delle generazioni future. Paolini critica l’attuale forma mentis per cui proviamo fiducia solamente verso passato, riponendo nel futuro, al massimo, una tenue speranza. Per lui, difficilmente si può continuare a tenere nettamente distinti esseri umani e macchine; e, se il messaggio non fosse sufficientemente chiaro, al termine dello spettacolo, prima di congedarsi dal suo pubblico, l’infaticabile affabulatore esorta esplicitamente gli spettatori alla riflessione sulle tante questioni che il suo bello spettacolo non si stanca di proporre a tutti noi.
Classe VP Liceo Fermi di Bologna
Letizia Fiorentini, Alice Lenzi, Francesca Minerva
(coordinamento prof. Ivan Montebugnoli)
Rubrica di commento
Io Robot, Io Persona
La pièce di Marco Paolini e Gianfranco Bettin, Le avventure di Numero Primo, mette in scena una società futura in cui sono presenti intelligenze artificiali, una delle quali, Arca Rerum, ha persino vinto il premio Nobel per la chimica e la fisica. Anche il personaggio principale, Numero Primo, è una intelligenza artificiale, ma rivestita del corpo di un bambino di sei anni, che ha la possibilità di crescere, di imparare, di morire. Numero Primo è quindi uomo o macchina? Alla fine del racconto, il padre Ettore, divenuto tale per atto notarile, scopre la vera natura del figlio e si chiede se Numero non sia solamente un algoritmo, ma la madre Echné gli risponde che in fin dei conti anche lui non è che un algoritmo biologico.
L’ottobre scorso l’Arabia Saudita è stato il primo paese a concedere la cittadinanza a un robot. Non è un caso unico: anche il Parlamento Europeo sta considerando l’ipotesi di dichiare certi robot “electronic persons”, il che avrebbe inevitabili conseguenze legali. Se un robot è una persona, ha anche diritti inalienabili. Spegnerne uno si configura come omicidio. Tenere un robot intelligente in casa diventa schiavitù. Ma altre e più impellenti domande si impongono: cosa significa essere umani? Se si può creare una persona con diritti e doveri per mezzo di una semplice stampante 3D, che valore abbiamo noi essere umani biologici? Se esistono macchine in grado di pensare, amare e sentire dolore, esse non devono anche essere protette dalla legge? Difficile dare una risposta a queste domande, ma Paolini ha almeno il merito di porre questioni importanti in modo ammiccante e accattivante, e ciò, per dirla con Dante, “non fa d’onor poco argomento”.
Classe VP Liceo Fermi di Bologna
Leonardo Bruni, Rachele Serrao, Francesca Pacifico, Sofia Grande
(coordinamento prof. Ivan Montebugnoli)
Dieci storie proprio così

Recensione
Ideato da un progetto teatrale nato nel 2002 per il San Carlo di Napoli il terzo atto di “dieci storie proprio così” colpisce per l’immediatezza, la forza ma soprattutto l’attualità del suo messaggio. Senza l’ausilio di una particolare scenografia, senza espedienti esterni ,i cinque giovani attori presentano degli sketch dinamici, dominano la scena cambiando di volta in volta prospettiva per ogni storia narrata, al tempo di musica, al ritmo di una chitarra e una batteria collocate sul fondo del palcoscenico. Alla musica è affidato anche il compito di sottolineare, enfatizzare, gli stati emotivi tra una storia e l’altra. “La parola” affiora da uno sfondo nero e prende vita attraverso le voci degli attori. Si tratta di una drammaturgia a quattro mani, infatti nasce da un’idea di Giulia Minoli e dalla regia di Emanuela Giordano. Protagoniste assolute dello spettacolo sono le storie, le vite “vere”, le testimonianze che rapiscono e coinvolgono emotivamente lo spettatore in sala. “Bruno Caccia, il procuratore di Torino ucciso dalla ‘ndrangheta nel 1983, “L’imprenditore arreso”, “la testimone di giustizia”, “il colluso”, “i ragazzi di strada” , “l’imprenditrice siciliana che decide di non pagare il pizzo”, “la professoressa”, che spiega come “le mafie seguono l’odore dei soldi…le mafie sono costellazioni…”,dice, sono solo alcuni esempi di queste storie. Nella rappresentazione cui abbiamo assistito vengono messe in scena non solo vicende che vedono come protagonisti figure maschili ma anche storie con al centro figure femminili. All’interno di queste storie, due sono particolarmente significative: ci hanno colpito le due donne protagoniste perché siamo abituati a considerare soltanto il ruolo maschile del “boss”. La prima è quella di Maria Stefanelli, particolarmente legata al mondo della criminalità perché moglie di un boss mafioso. Maria decide però di cambiare vita, testimoniando contro suo marito, anche per garantire a sua figlia una vita migliore. La seconda storia è quella di Federica Angeli, giornalista di Ostia, che inizia ad indagare sull’infiltrazione della mafia nell’economia della città. Una sera assiste casualmente ad una sparatoria e da li nasce la volontà di testimoniare e lo fa per il futuro dei suoi figli, nonostante il marito le chiedesse di lasciar stare. Le è stato detto “contro di noi non vincerai mai” ma questo non è stato un motivo di resa per lei, al contrario è stato un punto di partenza di una grande lotta. Entrambe sono esempi di donne che hanno trasformato la loro paura in coraggio ed è proprio questo l’aspetto che ci ha interessato. Non si tratta di azioni eroiche ma di azioni guidate dal buon senso civico che ci chiede quale sia la cosa giusta da fare lasciando da parte pericoli, difficoltà ed eventuali conseguenze. “Lottare e denunciare” si può, ed è la risposta che danno Maria e Federica. Queste donne sono la dimostrazione che si può fare qualcosa di significativo: forse non si vincerà ma l’importante è scegliere da che parte stare.
IV I liceo scientifico “E. Fermi” di Bologna
Chiara Albazzi, Giulia Bacci, Cernera Noemi, Madrigali Elisa, Soprani Eugenia, Ilaria Zambelli
(coordinamento: Prof.ssa Camilla Spina)
Rubrica di commento
Quando si pensa alla mafia, tendiamo ad immaginare gli attentati ai grandi eroi voluti dai boss delle cosche più importanti. In realtà sono le situazioni quotidiane che danno alla mafia il potere di compiere queste azioni. Questo spettacolo aiuta a riportare sotto i riflettori la portata di questa questione, mettendo in scena le storie di persone più vicine a noi di quanto crediamo. La stessa pizzeria in cui andiamo il sabato sera può essere gestita da un testimone di giustizia, come la discoteca più alla moda da un camorrista. Quanti di noi si pongono questi problemi? Problemi di cosa nostra di casa nostra? Si sono posti queste domande i ragazzi promotori di “Cortocircuito”, un giornalino studentesco nato nel 2009 da degli studenti che volevano semplicemente sapere cosa stesse succedendo nella loro città, nel territorio emiliano.
Spente le luci in sala si accende la consapevolezza di ciò che ruota attorno a noi e del nostro ruolo di cittadini attivi e consapevoli del fatto che la forza della mafia sta fuori la mafia, come dicono le donne del presidio di Tor Bella Monaca, una delle tante storie, portate in scena dagli attori, di donne che hanno iniziato una riqualificazione del quartiere in cui vivono sottraendo spazi e potere allo spaccio e alla microcriminalità organizzata.
Non si diventa onesti per decreto legge, per citare una delle loro frasi. Le informazioni che troviamo non vanno recepite in maniera passiva, ma vanno unite l’una all’altra e con la nostra esperienza personale, per poi elaborare una risposta condivisa. Il messaggio più importante che queste “dieci storie” ci hanno trasmesso è che non possiamo aspettare che siano gli altri a mobilitarsi. Avere paura e non agire non ci lascia la coscienza pulita, equivale a piegarsi, ad acconsentire alla mafia. Accusare lo Stato di non agire abbastanza non è la soluzione, perché questo non rappresenta il deus ex machina che risolve i problemi di tutti noi. Lo Stato siamo noi.
IV I liceo scientifico “E. Fermi” di Bologna
Buda Filippo, Fortunati Alice, Giovanni Mozzanega, Pallotta Luca, Maria Rambaldi
(coordinamento: Prof.ssa Camilla Spina)
È bello vivere liberi

Recensione
Lo spettacolo nasce da molto lontano: quando Marta Cuscunà – ideatrice, regista, drammaturga e attrice dello spettacolo – s’imbattè nella biografia di Ondina Peteani, scritta da Anna Di Gianantonio. Questa storia colpí Marta cosí tanto che decise di metterla in scena, con un’attrice in carne ed ossa e dei burattini per gli altri personaggi. In seguito Marta raccontò la sua idea al figlio di Ondina, preoccupato in un primo momento che i burattini non rendessero a pieno la drammaticità della storia. Poi Marta si rivolse a svariati drammaturghi affinché le scrivessero il testo, ma rifiutarono tutti. Fu allora che decise di seguire dei corsi di drammaturgia e in seguito, dopo aver vinto il Premio Scenario per Ustica nel 2009, riuscì ad ottenere i fondi necessari per mettere in scena lo spettacolo.
I burattini sono un elemento fondamentale dello spettacolo. In realtà sono di due tipi, che corrispondono a due esigenze artistiche diverse. Nella prima parte sono dei veri e propri burattini: la rappresentazione è comica, veloce, il registro popolare; i burattini alleggeriscono la durezza di ciò che viene rappresentato. Nella seconda parte sono dei pupazzi: l’atmosfera è drammatica, il ritmo più lento, la quiete -apparente- è spezzata da rumori agghiaccianti e improvvisi, i pupazzi sono macabri e freddi.
La vera star dello spettacolo, se così possiamo dire, è senza dubbio Marta Cuscunà. Versatile, espressiva, appassionata, l’attrice è stata abile nel trasmettere le emozioni ed enfatizzare i passi drammatici della storia, tramite l’interpretazione di più personaggi e il passaggio dalla recitazione all’uso dei burattini. Marta, dotata di una voce diversa per ogni personaggio della storia, ha catturato l’attenzione del pubblico dall’inizio alla fine dell’opera.
Nella messa in scena ha un grande valore l’aspetto simbolico. In primo luogo il colore rosso. Inizialmente, attraverso il fazzoletto color rubino, scandisce visivamente un punto di rottura tra il passato della protagonista sotto il regime fascista e il definitivo schieramento a favore del partito comunista. Successivamente il colore rosso viene utilizzato alla fine della scena con i burattini per spezzare il velo di comicità che si era creato. Marta conclude la scena con una mano tinta di rosso per simboleggiare la tragicità della guerra e sottolineare come Ondina si sia macchiata col sangue altrui per la prima volta. Infine la piuma rossa, che compare mentre le detenute nel lager intonano dei canti: simbolo di un ideale ancora vivo, dello spirito umano ancora presente in quello scenario macabro e tragico.
Un ulteriore elemento simbolico è il braccio del pupazzo-Ondina. Il braccio si spezza nel momento in cui le tatuano il numero. Per la protagonista è infatti come se le avessero irreparabilmente rotto qualcosa dentro che nessuno mai avrebbe potuto restituirle.
Dopo la scena della baracca di Auschwitz, l’attrice torna al centro del palco e cambia registro stilistico e comunicativo, passando dall’utilizzo di pupazzi al racconto della storia come narratore esterno. Marta narra così brevemente agli spettatori come Ondina sia riuscita a salvarsi ma non ha potuto partecipare alla liberazione e ai festeggiamenti. Il finale molto rapido e conciso fa capire che l’attenzione era rivolta alla vita partigiana della Peteani, e forse evoca una similitudine con i tempi di guerra lunghi e strazianti ma caratterizzati da finali repentini.
Rubrica di commento
‘È bello vivere liberi!’ è uno spettacolo che ha suscitato in noi molteplici emozioni, coinvolgendoci per tutta la durata. Nonostante la seconda guerra mondiale e il ruolo remissivo della donna siano elementi piuttosto distanti da noi, le capacità dell’attrice hanno fatto sì che potessimo immergerci completamente nello spettacolo e immedesimarci al meglio in Ondina, grazie anche alla giovane età che ci accomuna.
Marta Cuscunà ci ha fatto riflettere su come Ondina, nonostante la sua giovane età e il drammatico momento in cui è vissuta, abbia deciso di agire sempre di testa sua, senza influenze, mettendo al primo posto l’ideale e le cose in cui credeva.
Tra di noi sono nati due gruppi: chi avrebbe intrapreso la stessa scelta di Ondina e chi -forse per paura o forse per ideali contrastanti- non avrebbe compiuto lo stesso itinerario della Peteani. Tutti, però, siamo stati d’accordo nel riconoscere il coraggio e l’audacia di Ondina, una ragazza di diciassette anni che, con un semplice fazzolettino rosso e un ideale, è riuscita a modificare il corso degli eventi del suo tempo.
La storia raccontata da Marta Cuscunà è riuscita a folgorare e stupire i nostri animi: per questo crediamo che lo spettacolo meriti di essere visto dai giovani e dagli adulti.
Classe IIID Liceo Scientifico ‘Augusto Righi’ di Bologna
Francesca Balint, Daniele Battistini, Costanza Bellettini, Paolo Boaretto, Gian Maria Boccalupo, Luca Bulgarelli, Tommaso Caccavella, Filippo Caretti, Virginia Cavazzini, Edoardo Corradini, Elisa Demaria, Filippo Fazioli, Anna Fini, Joy Fructuoso, Leonardo Grossi, Tommaso Marchesini, Giulia Masina, Benedetta Natali, Giacomo Nicolini, Sara Placidi, Antonio Rizzi, Leonardo Saccani, Bianca Selvatici, Marco Senatore, Giulia Zappoli
(coordinamento prof. ssa Matilde Maresca)
Antigone

Recensione
Rubrica di commento
Classe IIGL ITC Mattei di San Lazzaro di Savena
(coordinamento prof. ssa Daniela Zani)