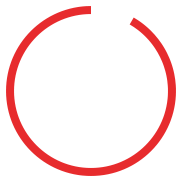Concorso Teatro in classe
Dopo l’ottimo esito dell’edizione conclusa, prosegue Teatro in classe, il concorso promosso da Emilia Romagna Teatro Fondazione che offre agli studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori di Bologna e Provincia l’opportunità di vestire per un giorno i panni di critici teatrali. Le classi seguiranno la stagione dell’Arena del Sole scrivendo per alcuni titoli in cartellone una recensione dello spettacolo e una rubrica di approfondimento che collega i temi trattati dalla messa in scena con l’attualità politica, sociale, culturale, di costume…
Recensioni
Riccardo3

Recensione
Il giorno 26 ottobre abbiamo assistito allo spettacolo intitolato Riccardo3, basato sulla tragedia di Shakespeare, nella sala Thierry Salmon dell’Arena del Sole, costituita da una disposizione teatrale moderna. La sala in cui si è tenuto lo spettacolo non era ampia e, grazie alla studiata disposizione dei posti, permetteva al pubblico di immergersi in una scenografia che ricordava un ospedale psichiatrico, costituita da oggetti semplici come una sedia a rotelle, un lettino, un armadio con dei teschi, di cui si comprendeva la funzione solo con lo sviluppo dello spettacolo.
La rappresentazione era una modernizzazione della storia ambientata da Shakespeare nel ‘600. La scena si apriva in uno studio medico. Le luci provenivano da sopra il palco e dal retro della platea ed erano di vari colori, per enfatizzare i sentimenti degli attori e diversificare le varie scene. Dal retro della platea venivano proiettate le ombre di un rapace e delle croci che rappresentavano le anime che Riccardo III aveva ucciso.
La musica accompagnava l’incedere di ogni scena ed erano presenti dei suoni come quello della lama quando veniva ucciso qualcuno, quello del mare, quando arrivano le navi del nemico e quello degli uccelli. Nel momento in cui arrivano le navi, c’è stata anche una melodia di sottofondo per rappresentare le scene di guerra.
Gli attori erano tre e due di loro, i coprotagonisti, avevano più ruoli, che dovevano incarnare in modo diverso con vari costumi e oggetti, tra cui un velo nero, una corona e un bastone. I personaggi non uscivano mai di scena, nemmeno per cambiarsi.
Riccardo III, ultima opera teatrale di Shakespeare è una tragedia sulla storia dell’Inghilterra, che conclude un racconto drammatico che il Bardo aveva già cominciato con Enrico IV. Il dramma inizia con Riccardo che elogia il fratello Edoardo IV, re d’Inghilterra. Riccardo si descrive come un orrendo gobbo, che cospira contro suo fratello Giorgio, che lo precederebbe come erede al trono, e lo conduce nella torre di Londra come sospetto assassino. Per riuscire nel suo intento, corrompe un individuo. Poi Riccardo entra nelle grazie di Lady Anna, vedova di Lancaster, il principe di Galles. Per assicurarsi il trono, decide di far uccidere tutti coloro che intendono interferire col suo progetto.
Francesco Niccolini si ispira a Shakespeare, ma, invece di chiamare il suo dramma Riccardo III, decide di intitolarlo Riccardo3, perché ci sono tre attori che interpretano tutti i personaggi della tragedia e sono Enzo Vetrano (Riccardo), Stefano Randisi e Giovanni Moschella.
L’opera finisce con la morte di Riccardo, ambigua dal punto di vista dello spettatore. Ci sono, infatti, diverse interpretazioni possibili, ovvero che questa sia un suicidio assistito o un’esecuzione. Questo si deduce dalla siringa, che può essere anche considerata come una lama.
Francesca Armenia, Anna Berti, Giulio Boschi, Elisa Cacciari, Valentina Dainesi, Yingxin Hu, Orpita Islam, Andreea Marcu, Anastasia Mella, Sara Mohammed, Lorenzo Victor Mondini, Imane Qerqeb, Greta Salvati
Rubrica di commento
Dopo aver visto lo spettacolo “Riccardo 3”, il nostro bagaglio culturale si è ampliato perché abbiamo visto una rappresentazione a nostro parere molto toccante e siamo rimasti impressionati dall’enfasi dell’attore che interpretava il protagonista. Secondo noi, la domanda che viene posta allo spettatore è quella di capire l’egoismo e la perversione mentale del personaggio che, per ambire al trono d’Inghilterra e quindi al potere, fa giustiziare tutta la sua famiglia; nello spettacolo il regista è stato bravo a rendere nitido ciò che c’era nel pensiero disturbato del sovrano, oltre ai suoi sensi di colpa. L’attore è riuscito a farci immergere pian piano nella sua instabilità mentale e a farci comprendere l’evoluzione del personaggio che va dalla convinzione assoluta di essere malvagio all’avere la paura cronica di essere spodestato e di essere privato del bene perverso del trono.
Lo spettacolo ci ha indotti a pensare che la fame di potere e la mania di prevalere sulla famiglia offuschino la ragione e inducano a fare pazzie, cosa che succede anche ai nostri giorni, quando di mezzo ci sono il potere o i soldi. Alla fine dello spettacolo ci siamo sentiti più consapevoli della fugacità della vita; ci siamo sentiti toccati dalla gravità delle conseguenze delle azioni di Riccardo.
Chiara Aliraj, Matilde Caneva, Matthias Mazzoni, Alessio Pescicolo, Federico Piazza
Classe 3 B – Liceo Linguistico Internazionale “C. Boldrini”
(coordinamento prof.ssa Cinzia Dezi)
L'anima buona del Sezuan

Recensione
L’opera, ultimata da Bertolt Brecht nel 1940, è ambientata nella regione cinese di Sezuan, dove tre dèi arrivano alla ricerca di un’anima buona . L’acquaiolo, che li attendeva con impazienza, si ingegna a trovare loro un alloggio per la notte, ma l’unica disposta a ospitarli è Shen-Te, una giovane prostituta che per alcuni aspetti richiama una Maddalena penitente. Per ricompensarla del suo buon cuore, gli dèi le fanno dono di 1000 dollari d’argento, con cui lei decide di aprire un negozio di tabacco. Senonché, tutte le persone bisognose della zona accorrono supplicandola di aiutarle. Di animo buono e incapace di negare il proprio soccorso ai bisognosi, per proteggersi dai questuanti, la giovane è costretta a prendere le mentite spoglie di un presunto cugino, Shui-Ta, che con le sue doti di uomo d’affari riesce a impedire che Shen-Te finisca sul lastrico. La figura del cugino è molto diversa da Shen-Te: il suo unico interesse è il tornaconto della “cugina”, anche a costo di sfruttare quanti lavorano per lui, e questo gli procura l’inimicizia dei beneficiati di Shen-Te. Poiché la cugina non viene più vista per molti mesi, Shui-Ta viene accusato in tribunale del suo omicidio. Alla scoperta che Shui-Ta è un alter ego di Shen-Te, i tre dèi, conclusasi in modo fallimentare la loro missione, decidono di andarsene lasciando Shen-Te in una situazione disperata e ignorandone le richieste di aiuto.
Nello spettacolo molti personaggi mostrano una notevole ambiguità. Per esempio, Sun maschera il proprio desiderio di diventare aviatore dietro il falso amore per Shen-Te, così come il barbiere mostra disprezzo nei confronti dei poveri, ma, per apparire buono agli occhi di Shen-Te, mette a disposizione dei protetti dell’amata le baracche dietro la sua lussuosa abitazione. Tutti, inoltre, esibiscono il proprio carattere con una mimica particolarmente accentuata e ostentata. Unica eccezione Shen-Te, i cui movimenti più contenuti evidenziano un carattere timido per quanto fermo nella sua fondamentale bontà d’animo.
L’utilizzo delle maschere gioca un ruolo fondamentale nell’opera: oltre a permettere agli attori di interpretare più personaggi, esse hanno anche un significato più profondo, dimostrando l’universalità del dramma rappresentato. Dietro i volti non meglio definiti dei personaggi, si nascondono tipi universali, presenti sia nel folklore cinese sia nella nostra commedia dell’arte. L’unica maschera che si distingue da tutte le altre, che mostrano pulsioni egoistiche, è quella di Shen-Te, profondamente afflitta e sinceramente buona. Solo in rari momenti dell’opera gli attori si tolgono la maschera per uscire dai personaggi e, infrangendo la finzione teatrale, commentare la scena che stanno rappresentando. Ammicca all’universalità del problema anche l’uso di differenti lingue e dialetti e la presenza in scena degli dei, i quali, come gli uomini, sono concentrati sui loro interessi: nella fattispecie, la loro carriera divina. Non è un caso che, nello scompiglio generale, nel finale essi si proclamino impotenti e abbandonino ai suoi problemi la povera Shen-Te.
La quale arriva alla conclusione che i comandamenti imposti dai celesti all’umanità sono ingiusti nei confronti dei buoni d’animo, poiché finiscono involontariamente per premiare le ingiustizie commesse dai malvagi. Nonostante ciò, l’invito finale agli spettatori perché cerchino una soluzione più giusta nella concretezza della vita dimostra ancora una volta che il teatro epico di Brecht è tutto un’esortazione all’impegno di ciascuno di noi per migliorare la società, a quell’engagement che, se oggi sembra passato di moda, rimane nondimeno presupposto indispensabile per il progresso materiale e morale di ogni Stato.
Arianna Cernera, Alexandra Gustomyasova, Matteo Lupo, Aleksandr Trento
Rubrica di commento
L’animo umano a confronto con la realtà
Uno degli argomenti principali della pièce è la povertà, una grave emergenza sociale anche al giorno d’oggi.
La mancanza di risorse economiche nelle zone povere del mondo ci induce a riflettere su come è organizzata la società attuale, in cui tutti vedono i problemi, ma nessuno agisce per risolverli, se non una ristretta cerchia di persone particolarmente sensibili alle sofferenze altrui. Le risorse per aiutare il prossimo sono scarse e spesso vengono messe a disposizione proprio dagli umili. Nello spettacolo, Shen Te, la protagonista, è di animo buono e cerca di soccorrere tutti coloro che hanno bisogno e si rivolgono a lei per aiuto, a tal punto da dover fingere di essere un’altra persona, severa, rigida e odiata, per sottrarsi alla rovina economica a cui la porterebbero le richieste indiscrete e sfacciate di tanti profittatori.
Oggi, una moltitudine di persone in difficoltà cerca di aiutare chi è ancora più in difficoltà, mentre i ricchi chiudono le loro porte e i loro cuori per paura di perdere i propri privilegi. Invece, dovremmo tutti cercare di aiutare gli altri, in modo da creare uno società in cui il benessere sia comune e accessibile a chiunque.
Nella povera regione cinese del Sezuan, è rimasta un’unica anima buona, la quale, nonostante debba utilizzare degli escamotage per salvarsi dalla rovina economica, cerca sempre di aiutare, senza secondi fini, tutti coloro che si trovano in difficoltà; nella nostra società, quante sono realmente le anime buone disposte a mettersi in gioco per aiutare il prossimo? Ne esistono ancora? Se, secondo Dante, nella sua Firenze , “giusti son due, e non vi sono intesi”, la domanda finale che Brecht rivolge agli spettatori non mira certo a tranquillizzarli, ma semmai a scuoterne le coscienze. Del resto, che il teatro brechtiano sia provocatorio e implicato con la realtà è nozione diffusa persino fra noi giovani e inesperti studenti di liceo.
Augusto Arcidiacono, Tommaso Bianchedi, Elena Lamieri, Serena Zheng
Classe 5 P – Liceo Fermi
(coordinamento prof. Ivan Montebugnoli)
La tragedia del vendicatore

Recensione
Al teatro Arena del Sole di Bologna, giovedì 10 gennaio 2019 è stata rappresentata La Tragedia del Vendicatore scritta dal contemporaneo di Shakespeare Middleton e messa in scena dal regista inglese Declan Donnellan che ne ha curato anche la drammaturgia, tradotta per il pubblico italiano da Stefano Massini.
La tragedia, scritta nel Seicento, riflette l’immagine di una società contemporanea in cui emergono l’ossessione per il potere, l’utilizzo della donna e del sesso per esercitarlo e, sopra tutto, il desiderio di vendetta come unico modo per ottenere giustizia.
Il primo impatto dello spettatore avviene con la scena aperta su un pannello rosso dalle sfumature sanguigne che fa da sfondo a tutto il palco e che, spostandosi con suoni metallici e inquietanti, per la durata dello spettacolo si aprirà su ambienti e situazioni diverse, abbinate alla gigantografia di famosi quadri rinascimentali di suggestione pop.
Ognuna di queste immagini fa da sfondo alle complicate vicende di una corte in cui all’ombra del potere avvengono crimini, complotti e vendette. Nella trama avviluppata dei molteplici personaggi emerge la figura di Vindice, prigioniero del ricordo della defunta amata Gloriana, uccisa dal duca, e ossessionato dal bisogno di vendicarla, poiché nessuna giustizia può condannare il potente capo dello Stato, che rimane così impunito; e così rimarrebbe anche lo stupro perpetrato da un figlio del duca, se questi non morisse per il complotto dei fratelli. Perseguendo la sua vendetta Vindice, con la complicità del fratello, valletto del figlio del duca, ordisce trame e utilizza travestimenti per arrivare a punire tutti, ad ogni costo, anche utilizzando il teschio mummificato della sua amata, usurpandone il cadavere. Gli intrecci delle vicende dei numerosi personaggi all’ombra del duca si snodano per tutta l’opera, ognuno di loro persegue il proprio fine, spinto dalla sete del potere, della lussuria, della ricchezza, dal desiderio di prevalere sugli altri, ad ogni costo. Lo sguardo dello spettatore deve fare i conti con la satira e il grottesco che spesso copre tutto di ridicolo, a partire dalle scene di sesso.
Si rende evidente come la vendetta accompagnata dalla rabbia porti ad azioni immorali, azioni che diventano lecite in uno Stato in cui la giustizia non esiste, schiacciata dalla tirannia del potere e della ricchezza. L’opera diventa quindi uno specchio della società odierna, dove non solo i potenti trionfano e comprano tutto e tutti, ma anche spesso le persone sono disposte a vendere se stesse e i propri figli pur di ottenere un briciolo di potere, o dove i fratelli o i figli cercano di uccidere i loro familiari per ottenerne l’eredità.
Nelle soluzioni sceniche proposte spicca l’uso della telecamera che bene rispecchia la necessità contemporanea di riprendere tutti gli aspetti della vita, anche quelli che dovrebbero rimanere più segreti, banalizzandoli. Anche i famosi dipinti dello sfondo, ormai stereotipi di una corte rinascimentale da scatola di cioccolatini, enfatizzano questa superficialità. E’ intrigante la scelta di girare i video in bianco e nero, quasi per smorzare i toni splatter delle scene di sangue e distinguere l’azione drammaturgica dai quadri dello sfondo. La performance degli attori del Piccolo teatro di Milano è di grande livello, coinvolgono lo spettatore nel vortice delle scene, senza un attimo di respiro.
Durante tutta la vicenda lo spettatore percepisce un’atmosfera di ambiguità, sia nella velocità della presentazione dei personaggi, di cui è difficile spesso ricostruire storie e retroscena, sia nell’esito della vicenda. Anche il finale lascia perplessi, ognuno esce carico di suggestioni, diversamente interpretabili. Forse, al di là del cardine della storia costruito sull’ evidente condanna del potere e della vendetta, rimane ampio il campo d’interpretazione di questa Tragedia del vendicatore; ognuno di noi può decidere se uscire abbattuto dalla consapevolezza delle brutture umane o intenzionato a riporre le proprie speranze nell’unico personaggio positivo, la giovane sorella di Vindice, che non cede ai ricatti subdoli del potere. Sembra quindi che la lettura middletoniana di Donnellan ci restituisca alla realtà odierna dell’alternativa femminile. Forse un mondo diverso è possibile?
Rubrica di commento
DAL PASSATO AL PRESENTE-LA CENTRALITA’ DELL’EGO
La tragedia del Vendicatore, dell’elisabettiano Thomas Middleton, spettacolarizza la crudeltà umana sotto forma di tragedia in una vicenda di intrighi di corte. Oggi il regista e drammaturgo inglese Declan Donnellan rende in chiave satirica la complessa vicenda di complotti e vendette che gira attorno a un principe rinascimentale, individuandone i tratti più moderni ricollegati alla nostra società, così imperniata sull’egoismo. E’ proprio questo il tema centrale della rappresentazione: l’ego che tende al potere, al denaro, alla lussuria, alla violenza e ad una spudorata sete di vendetta. Tutta la macchina scenica viene scatenata da morbose ossessioni e guidata da intrighi oscuri, talvolta sfruttando maschere, nascondimenti e video che ne esaltano, spesso in modo grottesco, la complessità volutamente inarrestabile.
Anche ai giorni nostri le dinamiche sociali e politiche sono dominate da ragioni egoistiche. Per il potere e il denaro ognuno di noi è pronto a rinunciare a ideali ritenuti sacri, andando contro ad etica e morale: sulla scena ciò ci viene esplicitato nella rinuncia a qualsiasi sentimento di fratellanza o solidarietà familiare nella scalata verso il potere dei fratelli o nella madre sciagurata che si lascia corrompere dalle offerte “generose” dei potenti e arriva a pensare di vendere la figlia. Qui si apre una nuova questione: l’oggettivizzazione della donna che porta a considerare frivolo persino lo stupro, poiché la pulsione prevale sul rispetto nei confronti dell’essere femminile. Sarà quindi un caso che proprio una ragazza sia l’unico personaggio integro della vicenda, l’unico in cui lo spettatore possa ritrovare una coerenza morale?
Pur di soddisfare i propri desideri di potenza, gli esseri umani sono capaci di spingersi fino ai confini della razionalità, sfociando, talvolta, in follia. Ciò li porta a commettere omicidi, a mentire, a tradire, a fingersi persone diverse, a non potersi fidare mai di nessuno e a rimanere, infine, soli, accomunati dalla grande menzogna che gira intorno alla loro vita.
Classe 3DL – Istituto Enrico Mattei di San Lazzaro di Savena
(coordinamento prof.ssa Daniela Zani)
Joie de vivre

Recensione
Lo spettacolo Joie de vivre, ideato dalla danzatrice e coreografa bolognese Simona Bertozzi e rappresentato per la prima volta il 14 dicembre 2018 al Teatro Storchi di Modena, vede in scena un ensemble internazionale di quattro danzatori e due cantanti specializzati nel canto difonico.
L’originale coreografia di Bertozzi si apre con una musica bassa e soffusa che cresce d’intensità nel corso della rappresentazione. Caratterizzano l’atmosfera scenica anche fumo e luci trascorrenti, quasi a dare l’impressione di una sera nebbiosa e di macchine che passano veloci su un’autostrada.
In principio il palco è vuoto, senza oggetti scenici; solo il colore del fondale cambia frequentemente, con l’alternarsi di tonalità calde (giallo, arancione, rosso) che distinguono le sequenze diverse di una specie di racconto. I danzatori entrano in scena per primi; si muovono a scatti, con gesti violenti e spasmodici, seguendo il ritmo sempre più martellante e intenso della musica. A queste movenze sono intercalate altre più morbide, sinuose e fluide, simili a quelle di serpenti o bruchi.
I corpi inizialmente danzano isolati, ma presto le coreografie, sul ritmo incessante di una musica quasi ossessiva, si fanno più complesse e arrivano a comportare l’intrecciarsi di braccia e di gambe. I danzatori formano vere e proprie strutture per consentire di sorreggersi a vicenda, lanciarsi in aria, riprendersi con sicurezza. Compaiono anche molti gesti di reciproco aiuto.
Presto entrano in scena i due cantanti, letteralmente rotolando sul palco; a differenza dei danzatori, che sono vestiti con colori chiari e naturali, i cantanti indossano luccicanti e rigide divise nere, su cui spiccano disegni di segnali stradali, forse a rappresentare il mondo artificiale e costruito dall’uomo che disturba la quiete della natura. Cantano con una tecnica particolare (il canto difonico) che enfatizza gli armonici naturali della voce, cioè in pratica consente a una sola persona di emettere e controllare due o tre note contemporaneamente. L’atmosfera creata dai cantanti è intensa e suggestiva.
A un certo punto essi hanno anche un altro compito: trasformare l’ambiente trascinando in scena un intricato groviglio di tubi di plastica verdi, bianchi e marroni con cui ricoprono i danzatori. I movimenti di danza, allora, servono ai corpi per liberarsi dal viluppo e riconquistare la libertà. Uno dei quattro danzatori rimane a lungo imprigionato dai tubi e compie una vera e propria faticosa lotta d’emancipazione. L’attenzione viene portata completamente su di lui: si spengono le luci e gli affanni del prigioniero sostituiscono la musica. La ricerca della libertà avviene in modo ansioso, come se il danzatore non riuscisse trovare una via di fuga.
La coreografia vuole farci capire che il raggiungimento della felicità non è così semplice e banale, anzi è un percorso che richiede sacrificio e fatica. Il senso dello spettacolo consiste sostanzialmente in questo: la natura, in continuo stato di angoscia, lotta per ottenere spazio vitale e spesso è l’uomo nel suo egoismo o nella sua indifferenza a negarglielo.
Lo spettacolo si conclude con un’immagine d’impatto: l’ultimo danzatore è in piedi, ansante, illuminato da un fascio di luce diretta; i tubi da cui s’è liberato gli pendono dalle spalle e la sua posa trionfante è coronata da uno sguardo stanco eppure fiero indirizzato al pubblico e oltre.
Rubrica di commento
Lo spettacolo distrugge ogni aspettativa dello spettatore, analizzando la “gioia di vivere” da un punto di vista diverso da quello che siamo soliti considerare. È un’originale rappresentazione dell’incessante ricerca da parte del mondo vegetale dello spazio vitale, ricerca spesso compromessa dall’uomo che, godendosi la propria felicità, causa residui dannosi all’ambiente in cui vive.
Il titolo dato allo spettacolo racchiude un messaggio implicito che vuole stimolare gli spettatori a una riflessione critica. Volutamente l’interpretazione è libera, in mano all’osservatore.
La parte che ci ha colpito di più è stata quella finale, grazie anche alla grande abilità del danzatore, unita alla musica e agli oggetti di scena. È stato il momento che ha suscitato in noi più emozioni, perché il messaggio dell’intero spettacolo vi è espresso chiaramente: la pianta, quasi soffocata, riesce faticosamente a vincere contro il groviglio di tubi, che rappresenta il deterioramento delle cose o l’inquinamento o comunque un residuo ingombrante e pericoloso per gli esseri viventi.
È un messaggio d’allarme, che riguarda tematiche al giorno d’oggi molto discusse: le piante, oppresse dall’impronta dell’uomo, crescono in modo poco spontaneo e si aiutano a vicenda per cercare la salvezza. Inoltre, è sottolineata la pericolosità dell’egoismo dell’uomo che, per la ricerca del proprio benessere e della propria felicità, in varie occasioni mette in pericolo la vita del mondo vegetale. Bisogna fermare l’aggressione alla natura prima che sia troppo tardi.
Classe 3DL – Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno
(coordinamento prof.ssa Irene Scaravelli)
Per il tuo bene

Recensione
La sera del 22 gennaio 2019 abbiamo assistito allo spettacolo Per il tuo bene, scritto e messo in scena da Pier Lorenzo Pisano. L’autore napoletano, nato nel 1991, grazie a quest’opera ha vinto la dodicesima edizione del Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli”.
“Io ho un figlio, cioè sono una madre” così si apre la scena, che, sin da subito, introduce il tema centrale dello spettacolo: la famiglia.
Il primogenito di due fratelli dopo tanto tempo torna a casa da una famiglia divisa dal tempo. Una madre cerca di rimettere insieme i cocci di un amore ormai freddo. La malattia di un padre assente li riunisce in un ambiente anonimo, a loro estraneo. Tra silenzi e imbarazzi vengono rievocati i ricordi di un passato di rimorsi e sensi di colpa; mentre i segreti del presente rimangono oscuri.
Il sipario che scorre permette allo spettatore di focalizzarsi sulla scena in corso e sugli attori che stanno recitando in quel momento.
All’interno della scenografia minimalista risaltano alcuni oggetti, che, durante la rappresentazione, vengono personificati: è il caso del tavolo inclinabile, che sostituisce il padre assente, o del bancomat (Nonnamat), il quale simboleggia la nonna paterna.
Assumono un ruolo importante anche i costumi, in particolare quello della madre, che con un semplice gesto dell’attore si trasforma nella nonna materna o nella tovaglia da tavola.
Sono pressoché assenti effetti sonori. Fa eccezione un forte rumore, che, ripetuto più volte e seguito dal buio totale, interrompe la scena in un attimo di tensione. Al colpo improvviso, infatti, lo spettatore sobbalza dalla sedia, provando una sensazione di ansia che rispecchia lo stato d’animo dei protagonisti.
Attraverso un linguaggio colloquiale, si alternano monologhi e dialoghi, caratterizzati da frequenti pause, che esprimono prevalentemente i sentimenti e le emozioni dei personaggi, il cui anonimato rende la storia quasi universale, così che anche persone molto diverse fra loro possano immedesimarsi.
Infine l’intimità dello spazio teatrale, la sala Thierry Salmon, contribuisce a rendere gli spettatori partecipi dell’ambiente familiare rappresentato.
Pisano ci offre uno sguardo critico sulla famiglia d’oggi, grazie a una drammaturgia, che tratta comicamente argomenti profondi, facendo arrivare efficacemente i messaggi al pubblico.
Nel complesso abbiamo trovato lo spettacolo avvincente e coinvolgente, poiché il regista, pur con ironia, riesce a evidenziare la difficoltà di rimanere uniti, quando, una volta cresciuti, il “dovere morale” di volersi bene viene a mancare.
Dal momento in cui i figli sono adulti, la famiglia diviene solo un gruppo di persone accomunate dai ricordi, i quali riemergono per tutto il corso dello spettacolo. I protagonisti riescono comunque a riscoprire i sentimenti che li legavano un tempo e che sono tuttora vivi; adesso questi devono essere coltivati con impegno e non dati per scontati, altrimenti si rischia di perderli nuovamente.
Il finale aperto e le tante domande a cui non è data risposta ci hanno permesso di immedesimarci in uno spaccato di realtà, che rispecchia e accomuna ognuno di noi.
Federico Bentivenga, Asia Bovinelli, Emma Canelli, Sean Caselli, Leonardo Coi, Alice Finotti, Francesco Graziani, Angelica Gregori, Matteo Marchi, Tommaso Massironi, Giorgia Montebugnoli, Federica Montesano, Enrico Mugnolo, Virginia Nanni, Federico Palmieri, Beatrice Panzacchi, Luca Rispoli, Amedeo Santini, Nicolò Spagna, Bartolomeo Velez
Rubrica di commento
“Ora bisogna salutarsi sul serio, che non si sa se ci rivediamo.
E ora ci vogliamo bene, si vuole meno bene a chi ti ama,
si vuole bene all’ultimo, quando è troppo tardi.”
Lo spettacolo è costruito attorno al concetto espresso da questa frase; ci si abitua all’amore e si dà per scontato, finché non si capisce che potrebbe non essere più possibile condividerlo.
Una famiglia, prima composta da persone distanti tra loro e quasi felici di esserlo, si trova a dover far fronte ai propri sentimenti a causa della malattia della madre.
All’indifferenza iniziale, identificata dalle espressioni di noia e seccatura dei due figli all’idea di doversi relazionare con la madre, subentra, nel finale, un affetto che comunque è ancora difficile esprimere, ma che piano piano è sempre più evidente. La malattia della madre riesce, infine, a riunire la famiglia tanto che il figlio maggiore si ritrova a combattere tra il desiderio di restare con lei oppure partire e tornare a casa.
Pur essendo una vittima, la donna sembra non temere per il suo futuro, ma piuttosto pare sollevata all’idea che quel dolore sia riuscito a farla riavvicinare ai suoi figli.
Se però non avesse sofferto di alcuna malattia sarebbe stato possibile ricostruire una famiglia?
Marco Calabri, Eleonora Lubisco, Virginia Morelli, Marco Plati, Alessandro Zardini
Classe 2 G – Liceo scientifico “Enrico Fermi” di Bologna
(coordinamento prof.ssa Paola Centineo)
Questi Fantasmi!

Recensione
FANTASMI E MASCHERE, FINZIONE E REALTÀ
“I fantasmi non esistono. I fantasmi siamo noi, ridotti così dalla società, che ci vuole ambigui, ci vuole lacerati, insieme bugiardi e sinceri, generosi e vili”. Forse non c’è altra citazione eduardiana che meglio sintetizzi la malinconica storia di Pasquale Lojacono, il protagonista di “Questi fantasmi!”, la celeberrima commedia di Eduardo de Filippo, portata in scena al Teatro Arena del Sole nella più completa fedeltà al copione originale.
In un antico palazzo napoletano del Seicento si svolgono intricate vicende di furti, di spiriti e di tradimento. Il sipario si alza: in un appartamento del palazzo seicentesco giunge il “guardaporte” Raffaele, seguíto da due facchini. Poco dopo compare anche il nuovo inquilino, Pasquale, che viene prontamente avvertito dal portinaio della presenza di fantasmi: proprio per sfatare questa leggenda, egli dovrà sempre mostrarsi sereno ed allegro agli occhi dei vicini e non dovrà stupirsi se alcuni oggetti dovessero sparire. Ben presto però scopriremo che i fantasmi in questa storia non esistono: è tutto un calcolato stratagemma di Raffaele per derubare di volta in volta i nuovi inquilini dell’appartamento. D’altra parte, Pasquale, giorno dopo giorno, trova misteriosamente nella sua giacca del denaro, che egli ha intenzione di investire per trasformare la sua nuova dimora in una pensione e riuscire così a far vivere dignitosamente se stesso, ma soprattutto sua moglie Maria. Quest’ultima tuttavia ha una tresca con il vero responsabile della comparsa dei soldi, un uomo in carne e ossa, Alfredo, scambiato da Pasquale per un fantasma benevolo.
Eduardo de Filippo riesce abilmente a creare un graduale dinamismo emotivo che, partendo da scene di carattere prettamente comico, raggiunge via via un clima umoristico che induce lo spettatore a riflettere. Ed ecco che nel finale emergono con notevole forza drammatica le difficoltà sentimentali della coppia: Maria è visibilmente consumata sia dal rimorso per aver tradito il marito sia dallo sdegno nei confronti di un uomo che, dal suo punto di vista, pur consapevole dell’adulterio, ha continuato ad approfittare degli aiuti economici fornitigli da Alfredo, mentre Pasquale è turbato e confuso per l’ostile silenzio della moglie. Al dramma umano si aggiungono le difficoltà economiche, in quanto il fantasma-benefattore sembra aver abbandonato Lojacono smettendo di lasciargli del denaro di nascosto e provocandone così il dissesto finanziario. Evidente appare anche il tema di matrice pirandelliana del travestimento, della maschera che l’uomo è costretto ad indossare in base alle circostanze in cui si trova. Degna di nota, e ormai divenuta un episodio cult del teatro novecentesco, è la “scena del caffè”, in cui Pasquale discorre dal balcone con il “dirimpettaio”, il professor Santanna, su come preparare un buon caffè: qui il riso sorge dal doppio senso della parola “becco”, che, oltre a indicare una parte della caffettiera, designa anche un marito tradito.
Questi fantasmi! è una commedia, o meglio, una tragicommedia, di grande efficacia scenica e che diverte il pubblico, ma che allo stesso tempo fornisce numerosi e profondi spunti di riflessione. Un’opera concepita più di settanta anni fa, tanto lontana nel tempo, quanto attuale nei contenuti e nelle tematiche, che infatti riguardano qualcosa che è senza tempo: i sentimenti umani. Condivisibile è la chiara volontà del regista Marco Tullio Giordana di non cambiare né il copione né la lingua di questo grande classico, lasciando così inalterate un’ambientazione e delle situazioni realistiche, in grado di far immedesimare in esse lo spettatore con spontanea immediatezza.
Federico Andreoli, Luca Biacchesi, Andrea Landi, Caterina Sacchetti
Rubrica di commento
SENZA DENARO LA PERDO, LA PERDO OGNI GIORNO DI PIU’
La forza dell’umorismo è quella di celare sotto la risata una riflessione su problemi universali: è questo lo strumento privilegiato a cui Eduardo ricorre per narrare, attraverso “questi fantasmi”, le difficoltà della vita quotidiana e la fragilità dell’agire umano di fronte ad esse: dai rapporti familiari, che col tempo, anziché rafforzarsi, si logorano sempre di più, ai problemi di carattere prettamente economico. Difatti, dall’opera emerge che, quando cerchiamo di salvare una relazione ormai consumata, e quando le difficoltà economiche sono tali da sovrastare la nostra serenità quotidiana, noi scendiamo a qualunque tipo di compresso, anche a costo di perdere la nostra dignità e rinunciare ai nostri princípi. È così che Pasquale, il protagonista della pièce, pur di salvare una relazione matrimoniale ormai ridotta ai minimi termini, accetta di calarsi in una rete di equivoci fatta di finte apparizioni, furti e donazioni da parte di fantasmi fittizi, che egli sceglie di lasciare entrare nella sua casa e soprattutto nella sua vita. Risolto così il problema del denaro, Pasquale si illude di aver messo fine anche alle sue difficoltà familiari, ma, rinunciando alla propria dignità, ha di fatto irrimediabilmente compromesso i già difficili rapporti con la moglie. Proprio in ciò l’amara commedia eduardiana rivela la sua eterna attualità: anche noi, infatti, siamo a volte indotti a pensare che il denaro possa risolvere i nostri problemi, mentre in realtà altro non fa nasconderli sotto una finta patina di borghese rispettabilità.
Quello che impressiona è come quest’opera, scritta nel 1945, in un’epoca e in un contesto differenti dai nostri, e ora rappresentata senza sostanziali modifiche rispetto all’originale, risulti ancora così attuale, facendo sorridere e al contempo riflettere il pubblico dei nostri giorni: è questa la forza dei classici, opere senza tempo che trattano di problemi umani e sentimenti universali.
Eleonora Pini, Greta Scapoli, Martina Sgarzi, Simone Trambaiolo
Classe 4 P – Liceo Scientifico Fermi di Bologna
(coordinamento prof. Ivan Montebugnoli)
When the Rain Stops Falling

Recensione
Entrando in sala, la scena si presenta aperta e subito incombente. Vari oggetti colpiscono subito lo spettatore: una vecchia cucina economica bianca, un attaccapanni con vestiti, cappelli e ombrelli e, in primo piano, un tavolo molto grande che si rivelerà un complicato congegno adattabile allo svolgersi della vicenda; infatti verrà diviso, frazionato, unito a seconda del congiungersi o disgiungersi dei personaggi tra il passato, il presente e il futuro della complessa vicenda. Solo dopo un po’ lo spettatore comincia e percepire la correlazione metaforica tra lo smembrarsi e il ricompattarsi di questo mirabile oggetto scenico e la storia cui assiste. Su tutto incombe un fondale dipinto rappresentante una pioggia scura, opprimente, che muta a seconda dell’illuminazione e su cui verranno proiettati spesso i nomi dei personaggi, collegati come in un grande albero genealogico di tre generazioni, o immagini di cielo, con le stelle o pieno di nuvole. La prima scena ci proietta subito nel futuro 2039 in cui un padre prepara un pranzo per un figlio che non vede da 20 anni e non ha nulla da offrirgli, solo un pesce, non si sa come piovuto dal cielo con la grande pioggia che non smette mai. Lo spettacolo pian piano travolge lo spettatore con un avvicendarsi di persone e momenti della loro vita, collegati da relazioni familiari o sentimentali, intrecciati nel tempo e nello spazio: entrambi si allargano, il tempo dal futuro a differenti momenti del passato, lo spazio da Londra alle vastità urbane e selvagge del continente australiano. A questo spessore complesso si aggiunge lo sdoppiamento dei personaggi femminili di cui ci vengono proposte due differenti età della loro vita, che spesso coesistono sulla scena: così una Gabrielle York giovane ci mostrerà tutti i nodi che la porteranno a diventare la vecchia Gabrielle York afflitta da Alzheimer. Questo filo del tempo ci tiene legati alla storia e il meccanismo dell’alternarsi di passato, presente e futuro viene sostenuto da battute simili ricorrenti, che acquisiscono significato solo alla fine. Così la citazione del Bangladesh che si sta allagando, da luogo comune diventa la realtà di un pianeta che affonda nella pioggia dovuta al riscaldamento globale; e il ricorso al mito di Saturno che mangia i suoi figli si rivela non solo legato alla relazione padre-figlio della storia e alla pedofilia, ma anche all’apocalittica realtà dell’umanità che distrugge il suo habitat. Pure il dare di bianco alle pareti, tentativo di pulizia di alcuni personaggi in momenti cruciali della loro esistenza, è ricorsivo e non risolutorio: il grigio, l’umido, la distruzione naturale e relazionale rimangono. La complessa rete di relazioni tra i personaggi, scaturita dall’innominabile perversione del padre, oltre che con un dialogo calibratissimo, si sostiene delicatamente sulla scena anche attraverso oggetti-totem: una zuppa di pesce, un cappello e una valigia di memorie. Sono connessioni importanti tra i personaggi, i luoghi e i tempi che la regista Lisa Ferlazzo Natoli ha saputo calibrare con cura e lo spettatore si ritrova affascinato dal riuscire a collegare tutto e ritrovarne i significati simbolici. Il difficile equilibrio dell’intrecciarsi di luoghi e tempi è sapientemente tenuto da tutti gli attori, quasi funamboli sospesi tra un punto e l’altro. Attraverso lo spettacolo “When the rain stops falling” Andrew Bovell ci fornisce gli “strumenti” per riuscire a comprendere l’intricato sistema dell’eredità sia in ambito familiare sia in ambito sociale e ambientale. Grazie ai trascorsi familiari che ci vengono mostrati, si può notare come il singolo riesca ad influenzare la collettività presente e futura: la colpa iniziale del padre fa sì che anche i discendenti non riescano ad instaurare alcun tipo di rapporto con il proprio padre, se non nell’epilogo della vicenda dove un padre e un figlio finalmente, nel 2039, si rincontrano visto il possibile esito apocalittico del pianeta. La coesistenza del passato e del presente che si realizza nella scena finale e culmina con il cessare della pioggia fa sperare in un superamento dei conflitti familiari, in una residua possibilità di salvare noi stessi e il nostro pianeta dalla distruzione.
Rubrica di commento
Una pioggia costante accompagna le vicende di una tragedia familiare che si dispiega piano piano, come una scatola cinese, agli occhi di noi spettatori rapiti da un alternarsi continuo di momenti passati, presenti e futuri. Non c’è mai il sole nel grigio mondo che Bovell esplora nelle vicende di una famiglia, scatenate da un orrido segreto di perversione innominabile, e un peso umido e claustrofobico perseguita anche gli amori, gli incontri, i dialoghi, le morti fino all’epifania finale, in cui tutto si disvela e trova il suo superamento. Sembra forte il legame con la tragedia greca, in cui le colpe dei padri ricadono inevitabilmente sui figli e i loro discendenti, ma qui il senso di colpa e di responsabilità si allarga a tutta l’umanità, colpevole della tragedia climatica dell’anno 2039 in cui termina la vicenda: il riscaldamento globale ha già spazzato via molti paesi sulle coste e anche i pesci non esistono più. Così in quest’opera si fondono mirabilmente individuo e società, dinamiche personali e scelte politiche, il peso del passato con le ipoteche sul futuro. C’è una valigia che lo sguardo dello spettatore è costretto a seguire sempre, contiene oggetti diversi di passati diversi di persone diverse, tutti mescolati insieme e il loro singolo significato si perde col tempo per acquisire quello di Memoria. When the rain stops falling ci costringe a riflettere sulle nostre eredità, sul peso delle nostre scelte, sull’inevitabile futuro distopico che ci attende se non cambiamo rotta e iniziamo a prenderci cura delle risorse del nostro pianeta, invece di dilapidarle.
Una frase riecheggia su tutta la vicenda “Lasciamo che i morti si prendano cura dei morti” e ci esorta a guardare avanti, a costruire il nostro futuro senza farci carico delle pesantezze e degli errori del passato; insomma a superare il peso del fato della tragedia e a incontrare scelte diverse, presenti e future. Così alla fine la pioggia smette.
Classe 3GL – ITC Mattei di San Lazzaro di Savena
(coordinamento prof.ssa Daniela Zani)
L'abisso

Recensione
Davide Enia è seduto al centro del palco affiancato dal chitarrista Giulio Barocchieri. Il monologo inizia e Davide racconta del sommozzatore, un uomo occupato in operazioni di soccorso a Lampedusa. Durante lo spettacolo Enia gesticola enfatizzando le parole pronunciate. La voce dell’attore viene inoltre accompagnata da un sottofondo musicale per riprodurre i sentimenti di angoscia e timore. Raccontando la sua storia Davide sottolinea il fatto che suo padre sia “muto” infatti tra loro ci sono sempre stati pochi cenni e poche parole. La prima visione di uno sbarco durante il quale provano sensazioni ed emozioni molto forti, che durante lo spettacolo è riuscito a trasmettercele tramite la gestualità e le parole forti, è un’esperienza che li ha traumatizzati ma allo stesso tempo li ha legati da qualcosa di sottile ma intenso: l’amore.
Durante una cena viene citato un altro sbarco che era stato vissuto da Paola, la memoria storica dell’isola. E’ stato un trauma per Paola infatti sa raccontare ciò che è accaduto ma con alcune lacune.
Oltre a questi naufragi, ne viene raccontato anche uno di tipo personale. Davide Enia lo vive con lo zio, il quale, dopo essere guarito da un tumore, scopre di averne un altro. Ha un rapporto stretto con suo zio, infatti si contattano spesso, però, non gli rivela mai i suoi veri sentimenti e sensazioni su ciò che vive a Lampedusa, per non dargli ulteriori preoccupazioni. Davide va in ospedale a trovare suo zio ormai morente. Dopo avergli mostrato delle bozze del suo futuro libro, cominciano a parlare di morte. Davide stringe gli occhi per trattenere le lacrime: queste hanno avuto un ruolo fondamentale in quel periodo perché erano le uniche che riuscivano ad esprimere il puro dolore impulsivo che provava. Alla fine, l’attore narra il mito di Europa e chiude la scena con una frase d’effetto: “Siamo tutti figli di una attraversata in barca sul mare scuro.” Dobbiamo ricordarci che siamo tutti uguali.
Rubrica di commento
Immigrazione in Italia
Cos’è l’immigrazione? L’immigrazione è il trasferimento permanente o temporaneo di pensare in un paese diverso da quello d’origine. L’immigrato scappa dai problemi, del proprio paese, come guerre. Questo fenomeno persiste anche al giorno d’oggi avendo come protagonisti persone provenienti dall’Africa, India e America Latina.
Secondo alcune statistiche l’Italia ha solo l’8,3% di immigrati, invece l’Austria ne ha il 15,2%. In Italia si parla molto d’immigrazione, soprattutto in politica. Alcuni partiti politici vogliono creare, con una sorta di strategia, l’idea di un nemico inesistente (l’immigrato) a cui dare la colpa dei vari problemi del nostro paese, mentre altri partiti dicono che sia giusto.
In Italia cresce l’intolleranza verso gli immigrati, in alcuni luoghi comuni. Quelli più adoperati sono:
“Ci stanno invadendo”. Questa frase è utilizzata per indicare l’enorme quantità di persone che sbarcano in Italia, anche se non rimangono ma vanno in altri paesi.
“Ci rubano il lavoro”. Utilizzata per incolpargli della disoccupazione, quando invece si occupano di lavori duri e sottopagati.
“Mantenerli costa”. Indica il fatto che noi italiani paghiamo lo stato, che usa i soldi per il loro mantenimento, cosa non vera perché in Italia tutto ha un costo elevato.
Tutto questo ricorda la dittatura attuata da Hitler in precedenza. Affinché questo regime di terrore non si ripeta bisogna iniziare a smettere di crederci superiori ma cominciare a pensare a chi non è fortunato come noi.
Classe 2R – Liceo Sabin di Bologna
(coordinamento prof.ssa Marina Melotti)
Menelao

Recensione
Due attori per tanti personaggi, uno spazio per tanti ambienti, così Enrico Deotti e Giulia dall’Ongaro narrano Menelao, un uomo senza vita che si confronta con l’immagine che vorrebbe di se stesso.
Menelao è tornato dalla guerra di Troia indenne, nella sua dimora lo aspetta Elena, la donna più bella del mondo e assieme ad essa un mare di ricchezze, nonostante ciò è infelice.
Agogna la gloria eterna ma non riesce ad ottenerla, interpella gli dèi, invidia la morte eroica del fratello Agamennone, chiede al rapsodo di riscrivere il suo personaggio, affinché lo aiuti a realizzare il suo desiderio.
Cupa, buia, a tratti tetra, così si presenta la scenografia che accompagna il dramma esistenziale di Menelao.I giochi di luce, ma soprattutto di ombra sono i veri signori della scena e grazie a questi espedienti viene conferita dinamicità ad una rappresentazione oggettivamente statica; lo spettatore respira la stessa aria di Menelao, circondandosi dello stesso buio che oscura l’anima dell’uomo.
In tale oscurità lampi folgoranti risaltano maschere, statue, teste, marionette e fantocci che paradossalmente concorrono ad incrementare l’inquietudine della scenografia; tra queste hanno ruolo di spicco quelle degli dèi. Zeus, un’enorme testa di cartapesta, è affiancato da statue di diversi materiali che rappresentano l’intero Olimpo, il quale immobile, dal fondo del palco, sembra osservare le vicende che si svolgono in prossimità della platea. Qui si trova una cassa di legno che, nelle diverse scene, ha funzione di tavolo, di studio e addirittura di camera da letto.
Parole e atti si alternano affiancati da inserti musicali che scandiscono all’unisono il passare del tempo.
Altro aspetto di spicco sono l’espressività verbale e gestuale degli attori che esaltano magistralmente le battute di un copione diretto e schietto, grazie alla sapiente regia di Dario Carnevali, alternando la solennità tipica del registro tragico ad un linguaggio più comune.
Tra le note coinvolgenti e la suggestiva sceneggiatura lo spettatore viene invitato a riflettere sull’eterna insoddisfazione e sulla logorante infelicità di Menelao, il quale, troppo occupato a rendere glorioso il suo anonimo passato, sceglie di non vivere il presente e di rinunciare al futuro.
L’uomo non accetta di vivere una vita apparentemente perfetta e si affligge invece nella vana ricerca di tutto ciò che non può avere: onore, gloria, felicità.
“Quando eri di un altro almeno potevo desiderare qualcosa che non avevo. Adesso non mi resta nemmeno quello.”
Questa frase rivolta a Elena da Menelao invita a riflettere su come il valore delle cose diminuisca quando le si ottiene. Così ormai tutto ciò che possiede ed è reale ha perso valore per il protagonista. Menelao si illude di vivere impiegando i suoi giorni a dare un senso al suo passato cercando la ragione della sua infelicità ovunque meno che in se stesso.
Rubrica di commento
Menelao è il dramma di un uomo: è il dilemma tra apparenza ed essenza.
Nel corso dello spettacolo il dialogo fra Menelao e il rapsodo ci permette di riflettere su questi concetti: come Menelao vuole che il cantastorie riscriva la sua storia in una versione eroica e quindi in un contesto illusorio, così al giorno d’oggi gli utenti vogliono che i social network creino un’immagine fittizia di se stessi. Inoltre, il protagonista pur avendo tutto quello che si possa desiderare, ricerca l’unica cosa che non potrà mai avere: la gloria eterna, la quale si ottiene con l’essere ricordati dopo la morte. E’ quello che cerchiamo anche noi usando piattaforme online? Al giorno d’oggi, non usiamo i social con lo scopo di essere ricordati per sempre; li utilizziamo in quanto postando foto, aumentiamo il numero delle persone che ci seguono.
Così facendo, noi riceviamo gratificazioni nel numero di like, di commenti, di condivisioni; insomma possiamo dire che usiamo i media soltanto per apparire e non essere.
Gli interrogativi che si pone Menelao, sono gli stessi che ci poniamo noi oggi, essi non sono cambiati nel tempo, ma diversamente dal protagonista, cosa potremmo fare? Forse si tratta solo di iniziare a vivere.
Classe 3O – Liceo Enrico Fermi di Bologna
(coordinamento prof.ssa Camilla Spina)
F. Perdere le cose
Recensione
I lost my balance (ho perduto il mio equilibrio) è un’affermazione di F. nel dialogo con la compagnia teatrale Kepler 452.
Chi è F.? – Io sono io – è la sua risposta.
Ai Kepler piace raccogliere storie, incontrare e incontrarsi, sanno che corrono rischi, che sfidano modi consueti di fare teatro ma le modalità della sfida sono così interessanti e rispettose dell’essere umano da farci diventare loro indiscutibili ammiratori.
Lo spazio scenico è vuoto, grigio, insapore, qualcosa di simile all’atrio del dormitorio dove hanno incontrato la mano alzata di F. che affermava: io – sono – io.
Seguono dialoghi, prima ermetici poi via via stratificati con elementi decifrabili e indecifrabili, ostacoli e aperture.
F. non parlerà del suo passato, poche cose del suo presente: è stato in strada, ha avuto allucinazioni, ha perduto i documenti; emergono elementi di probabile realtà: è di origine nigeriana, è in Italia da venti anni, ha lavorato per quindici, ha versato i contributi, ha perduto i documenti, il permesso di soggiorno e l’equilibrio psichico.
Più la perdita e l’ignoto assumono forme e consistenza più i Kepler si ostinano in questo incontro di presenza-assenza.
L’incontro nella perdita è la coordinata della narrazione, ma non si tratta di una perdita volta ad un ritrovamento, a meno che per ritrovamento non intendiamo i ribaltamenti che provoca l’Alterità. Difatti, è in questo ribaltamento che la loro macchina teatrale si perfeziona. I Kepler ci proveranno a portare F. in teatro ma ci sono troppi ostacoli, burocrazie, vincoli, leggi, trattati, regolamenti e impedimenti.
Anche se F. non lo sa, indica loro la direzione da prendere e contemporaneamente essi difendono quella storia, una storia autentica nella quale l’Altro è riconosciuto e riconoscibile a partire da mancanza e perdite, niente a che vedere con le abituali caratteristiche positive di individuazione dell’essere umano.
L’incontro avviene nella relazione tra realtà che restano in parte misteriose e accettate come dati dell’esperienza: a Warri in Nigeria, nella notte in cui non c’è luce elettrica, nel deserto dove è veramente molto caldo, a Bologna, nel dormitorio davanti la Tv, a teatro nelle vesti di una cassa auto parlante, giornate passate nell’abisso, giorni di campi arati con l’albero metafisico al centro, mia madre nella vestaglia rossa.
I temi della migrazione, extraterritorialità, marginalità, fragilità umana sono talmente pieni di dolore che si deve scongiurare lo stereotipo e i Kepler sono magistrali in questo, non si prefiggono di trasmettere messaggi, mai intenti pedagogici o modalità standardizzate: ciò che conta è la storia in sé, la storia di un essere umano, uno di noi.
Padroneggiano con talento il medium, sanno che è il messaggio, e qui il medium è il teatro nei suoi straordinari s – quilibri, un teatro che non chiede conferme: il teatro è teatro, F. è F., il diverso non è Altro da noi.
E’ una narrazione che evade dalle definizioni, che si divincola dalla facile emotività pur emozionandoci nel profondo attraverso l’anti narratività di F. e l’avvertimento affettuoso della madre di un Kepler – ognuno di noi ha in sé un barbone – rincantucciato laggiù nel fondo -. Molti di noi sarebbero d’accordo nel chiamarlo libertà e, nelle sue perdite, l’universalità della narrazione teatrale: l’assenza è una presenza nel lavoro dell’attore, il suo corpo è lì nel-mezzo tra uno spazio interiore e uno esteriore, è lì che incontra F. perché F non rappresenta: F. è.
Rubrica di commento
“Che cosa si racconta di una persona che non si racconta e non è in scena per mostrarsi in assenza di un racconto?”
Questa diventa la domanda della compagnia teatrale Kepler 452 a partire dagli incontri con F. in un dormitorio della città.
F., nigeriano, da vent’anni a Bologna, ha perduto tutto: documenti, permesso di soggiorno, lavoro, equilibrio psichico.
Perdere le cose è una sfida artistica che coinvolge gli spettatori negli incontri della compagnia con F.: un percorso instabile, frammentato, ostacolato, per fare sì che F. possa raccontarsi in scena. “Siamo andati nel dormitorio per senzatetto perché quando pensi a qualcuno che ha perso le cose è facile che ti vengano in mente i barboni”.
Le difficoltà e le incertezze non possono procurare nient’altro che sconforto negli attori e dubbi su quale sia la cosa giusta da fare. “Come si porta in scena un assente? Che cosa, di lui, ci riguarda?”
Perdere le cose non vuole essere uno spettacolo sulla marginalità sociale, sull’immigrazione, è piuttosto una storia di presenza-assenza, un essere umano senza luogo senza elementi per esserci, F. è.
Le esistenze e i pensieri della compagnia si capovolgono nei dialoghi con il protagonista che vorrebbero portare in scena e portare la storia dell’Altro in modalità consuete farebbe perdere energia e forza al tema perché il vero tema è F., un’identità, un’alterità da narrare.
Non si tratta di uno story telling emotivo con le sue verità, siamo di fronte ad un lavoro originale che evade dalle definizioni, con stratagemmi teatrali magistralmente espressi.
Classe 3N – Liceo Sabin indirizzo economico-sociale
(coordinamento prof.ssa Mirca Buttazzi)
Il canto della caduta

Recensione
Grida, boati ed esplosioni riempiono il teatro. Il canto della caduta, con i suoi tanti volti prende forma. Le menti degli spettatori vengono costantemente sopraffatte dall’angoscia e dall’inquietudine di scoprire le sorti della guerra narrata.
Marta Cuscunà nel suo spettacolo riesce ad avvicinare il pubblico al tema crudo e delicato della guerra attraverso lo stile fiabesco di un’antica leggenda ladina. I bambini-topi, eredi dell’antico regno di Fanes, un tempo prospero e pacifico sotto il governo della loro regina, sono ora vittime della brutalità di popoli nemici. Si nascondono sotto le pieghe della terra, in una buia ed umida caverna, ricordando il felice passato, mentre uno stormo di corvi, dall’alto, si confronta con leggerezza ironica sulla realtà di morte e distruzione che si consuma davanti ai loro occhi. L’autrice-regista anima da sola tutti i personaggi riuscendo abilmente ad interpretarli, modulando di volta in volta l’intonazione della voce e muovendosi velocemente e silenziosamente nello spazio scenico per manovrare pupazzi e, attraverso joystick, meccanismi animatronici. Questi hanno completamente sostituito il ruolo di attori e attrici e sono il punto di forza affascinante e innovativo dello spettacolo, con l’applicazione al mondo del teatro di effetti speciali abitualmente utilizzati nell’ambito cinematografico.
L’ambiente bellico è riprodotto anche grazie ad un grande schermo posto al centro della scena che, muovendosi verticalmente ed emanando fasci di luce accecanti e psichedelici, illumina il teatro e a tratti disturba volutamente la percezione visiva degli spettatori. L’ambiguità delle didascalie proiettate con diversi colori crea un dialogo che solo parzialmente si svolge tra i personaggi. Il più delle volte ha la funzione di interrogare un pubblico che, con l’avanzare del racconto, si trova ad essere sempre più coinvolto e stimolato a riflettere sul dolore e sulle scelte che la guerra porta, soprattutto a carico di vittime deboli e impotenti come donne e bambini, destinati a cadere a causa di una perversa logica, tutta maschile, di predominio.
Nella dinamica della scena, all’interno dei diversi livelli comunicativi che lo spettacolo propone, il Canto della Caduta risuona ugualmente triste e inesorabile nella voce di chi lo denuncia e di chi sarebbe addirittura disposto ad andargli incontro per attraversarlo, per uscirne e ritrovare un’epoca perduta di pace, purtroppo destinata a non tornare mai più. Ma lo spettacolo si apre anche a numerose altre riflessioni su molteplici argomenti, che vengono affidate alla sensibilità dello spettatore.
Un plauso va al talento della Cuscunà, per essere stata una presenza invisibile, continuamente in movimento sulla verticalità della costruzione scenografica, rivelando la possibilità di mettere in risalto le proprie qualità pur senza manifestarsi.
Rubrica di commento
Il canto della caduta mette in scena un’atmosfera di inquietudine e sofferenza. Lo spettacolo, infatti, sembra essere una vera e propria denuncia sociale non solo nei confronti dell guerra, ma anche della violenza e della distruzione gratuite che essa porta con sé. Un problema attualissimo, davanti al quale troppe volte ci si pone come passivi e inermi spettatori.
Se infatti in tutte le cose esistono più punti di vista, nello spettacolo emerge non solo la posizione di chi vive in prima persona il conflitto, sia che lo scelga o che vi combatta o ne subisca le drammatiche conseguenze, ma anche quella degli spettatori, che osservano e commentano senza agire, forse per comodità o per arricchirsi, proprio come i corvi che, pur provando ribrezzo, si nutrono delle vittime, anche di quelle innocenti.
I corvi appollaiati sui rami della scena sono allora la nostra società, sono coloro che, guardando le notizie in televisione, non prendono una posizione e, pur essendo al corrente dei fatti, non intervengono; sono coloro che vendono le armi a popoli in guerra alimentandone la devastazione, arricchendosi a discapito di tante vite, soprattutto innocenti; sono i politici che chiudono le frontiere e non guardano in faccia a nessuno. Lo spettacolo ci interroga singolarmente e impone domande urgenti: non sarà arrivato il momento di far tornare in vita Amargi, il regno della libertà?
Classe 3A – Liceo Fermi di Bologna
(coordinamento prof.ssa Daniela Salcoacci)
Ragazzi di vita

Recensione
Caldo torrido, arsura e fetore: su questa atmosfera si apre il sipario e si inserisce la storia dei “ragazzi di vita”.
Lo spettacolo si svolge su un palcoscenico dalla luce accecante e caratterizzato da una scenografia essenziale, funzionale ai numerosi cambi di scena. A renderla particolarmente efficace contribuisce l’accompagnamento descrittivo del narratore che, attraverso le parole di Pasolini, con crudo realismo, sembra quasi ricreare davanti ai nostri occhi la Roma delle periferie.
Così come nel romanzo, lo spettacolo presenta scorci sulla vita delle borgate romane, brulicanti di giovani “pischelli”, come Riccetto e Agnolo, in cui prevale sopra ogni bisogno quello di vivere, vivere al massimo, giorno per giorno, attraverso qualsiasi espediente.
In uno sfondo di palese delinquenza, prevale spesso l’innocenza, o meglio, l’ingenuità dei ragazzi, assetati di vita piuttosto che di denaro. I giovani vengono infatti sorpresi nelle diverse scene a rubare borsette e a saccheggiare magazzini, ma subito dopo, li vediamo distesi per terra a rotolarsi dalle risate e a raccontarsi le loro bravate.
Se molti passaggi sembrano essere tenuti insieme dalla figura di Riccetto, il brulichio vivace della borgata è reso attraverso la coralità dei personaggi, le cui battute si succedono incalzanti e scanzonate, e dai quali emerge ogni tanto una voce solista.
I personaggi ci raccontano le loro storie, ne avvertono la tragicità, ma allo stesso tempo, attraverso lo stilema della terza persona, mantengono sempre una giusta dose di impersonalità, un escamotage che sin dal realismo di Verga ha rilevato la sua grande potenza narrativa.
Il copione riprende quasi letteralmente le parole di Pasolini, la cui magistrale capacità descrittiva ridà vita, con toni espressionistici, alla Roma del dopoguerra, ai suoi paesaggi e ai suoi personaggi ai margini della società: una donna “con la ciccia che schizzava da sotto il vestito”, un ubriaco sul cui viso “una ragnatela di rughe si spostava su e giù (…) sopra la pelle tirata e imbolsita dal vino”.
Nella descrizione si inseriscono abilmente i dialoghi, che riproducono un dialetto romano graffiante e scurrile.
All’”io” narrante, che parla attraverso i personaggi, si sovrappone un narratore vero e proprio, che nel racconto si delinea sempre più come spettatore che assiste in disparte alle vicende: un Pasolini che si aggira per le borgate, ne comprende le dinamiche, ma che allo stesso tempo se ne sente inevitabilmente estraneo.
Un filtro letterario, infatti, sembra frapporsi fra narratore e personaggi, anche se il primo ogni tanto cerca di rincorrerli e stare al loro passo. Questo filtro emerge chiaro quando intenzionalmente viene citato il sonetto “Er cane” di Belli, o nella scena del glossario, esplicitamente metateatrale, che per un attimo si distanzia dalla storia.
Inevitabile anche evidenziare il chiaro riferimento alla “Deposizione” di Rosso Fiorentino che, così come già Pasolini aveva fatto nel film “La ricotta”, viene ripresa per l’allestimento della prima scena.
Nella rappresentazione teatrale si conservano bene due aspetti fondamentali del romanzo: da un lato, infatti, è ravvisabile un tono poetico e sognante, che distingue la narrazione pasoliniana dal Neorealismo, riscontrabile, per esempio, quando Riccetto salva una piccola rondine dalle acque del Tevere, o quando il fusajaro, seduto sui sedili di un tram, sogna di indossare il tanto desiderato maglione azzurro che aveva visto in una vetrina. Allo stesso tempo permane, implacabile, la ferocia delle leggi che, spietatamente, dominano il mondo sottoproletario: “a Pietralata non c’era nessuno che provava pietà per i vivi, figurarsi cosa cazzo provavano per i morti”.
Uno di questi registri è però destinato a prevalere sull’altro. Il tono leggero, quasi di intrattenimento, che investe per gran parte dello spettacolo la materia trattata, anche grazie alle canzoni introdotte nella rappresentazione, è eliminato totalmente nel finale: la ferocia si è impadronita anche di Riccetto, ormai “imborghesito”.
Si inserisce anche in questo finale il filtro dell’io narrante: la vera barbarie non riguarda l’essenza del mondo di borgata, ma piuttosto l’insinuarsi in questo del cinismo veicolato dall’ideologia borghese. E’ ravvisabile, in questa paradossale prospettiva, una sorta di idealizzazione pasoliniana del mondo popolare, brutale sì, ma comunque autentico.
Rubrica di commento
I protagonisti del romanzo di Pasolini ‘Ragazzi di vita’ sono un gruppo di giovani emarginati delle borgate romane, che trascorrono le loro giornate spensieratamente, alla ricerca di qualche soldo per divertirsi, o semplicemente mangiare. Lontani dalla scuola, appartenenti a famiglie disgregate , povere, spesso violente, incapaci di trasmettere loro una morale e dei codici di comportamento, vivono nell’illegalità in edifici fatiscenti , inseriti in una periferia desolata. Questo contesto degradato determina il loro carattere esuberante e il loro modo di agire, sconsiderato, irrazionale e guidato da passioni e desideri che devono essere immediatamente soddisfatti.
In “Ragazzi di vita” si possono trovare diversi elementi tipici del romanzo di formazione. Chi, guardando il “Riccetto” non ha pensato a figure come il Giovane Holden o il più recente Alex di “Jack frusciante è uscito dal gruppo” ? Chi non ha trovato delle somiglianze tra questi ragazzi e altri appartenenti a bande giovanili, protagoniste di celebri romanzi come la “ Guerra di bottoni” o la “Paranza dei bambini”? Ozio e bravate compongono la loro quotidianità, ambientata, in questo caso, nella borgata romana del secondo dopoguerra. Se nella “ Guerra dei bottoni “ i ragazzi tornano a casa in mutande, qui i giovani lo sono fin dall’inizio della rappresentazione teatrale. I piccoli furti dei borgatari sono divenuti i traffici su larga scala dei “paranzini”.
È inevitabile chiedersi oggi chi sono i ragazzi di vita. Pasolini . in particolare negli “Scritti corsari”, accusa il progresso economico e sociale del dopoguerra di aver disgregato l’identità culturale dei figli dei sottoproletari, che cominciano a guardare con desiderio la vita dei borghesi. In una delle scene finali dello spettacolo vediamo, ad esempio, “ Er Morbidone” che, passando davanti una ad vetrina, è ammaliato da un maglione e sopra al tram, sulla via di casa, fantastica di indossarne uno. Il personaggio di Pasolini sembra profetizzare lo sfrenato consumismo del nostro presente.
Dal punto di vista sociale, in Italia, la situazione è, per fortuna, immensamente migliorata , ma lo spettacolo “Ragazzi di vita” fornisce uno spunto di riflessione su cosa sia l’emarginazione e in che modo si manifesti nella società contemporanea.
Se oggi i bisogni fondamentali sono, quasi per tutti, soddisfatti , cresce sempre più il divario da ricchi e poveri e i giovani faticano a trovare un lavoro corrispondente ai loro desideri e alla loro formazione. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta il boom economico aveva creato un ascensore sociale che permetteva di raggiungere un certo benessere anche a chi era nato in famiglie appartenenti alle classi sociali meno fortunate. Oggi vediamo, però ,come questo fenomeno si sia arrestato: tanti giovani non riescano a trovare un impiego anche dopo anni dalla fine degli studi. Altri invece sono costretti a cercare all’estero nuove opportunità. Soprattutto in certe zone del paese, molti ragazzi abbandonato la scuola e cadono nella trappola della malavita.
Classe 5B – Liceo Fermi di Bologna
(coordinamento prof.ssa Paola Poluzzi)
Maleducazione Transiberiana

Recensione
ALLERTA SPOILER
Come fa uno spettacolo a mostrare cose conosciute da tutti da un altro punto di vista?
Come è possibile riscrivere le favole e i cartoni animati in chiave contemporanea?
Queste sono solo alcune delle domande che ci propone Maleducazione Transiberiana e che ci invitano a riflettere sui modelli che ci vengono presentati oggi e sui quali si possono avere punti di vista differenti e contradditori. Lo sceneggiatore ha strutturato lo spettacolo in sei capitoli nei quali si affronta la relazione fra la società e l’educazione infantile Il teatro ci chiede di impersonificarci in personaggi che seguono una linea temporale ben precisa, coerente con quella che ci segue durante l’arco di vita. Lo spettatore si identifica prima con il bambino al quale viene raccontata una fiaba, poi nell’adulto che cerca di capire se è riuscito a realizzare il mestiere sognato da piccolo, successivamente nel ruolo di genitori come coppia e infine nel singolo genitore convinto della propria idea educativa spesso in competizione con l’altra.
Il centro dello spettacolo rimane quindi la figura dell’educatore, oggi ieri e domani che si deve interrogare sui modelli che propone la società.
La prima scena si apre con la figura di Pisolone, un coniglio apparentemente innocente, che comincia a raccontare la fiaba di Cenerentola in chiave attuale utilizzando lo stesso schema narrativo della fiaba Disney. Non manca nulla per descrivere la società di oggi e di come per realizzarsi occorra basarsi sull’apparenza.
La seconda scena ci mostra con un filmato alcuni bambini che raccontano cosa vogliono fare da grandi e immediatamente dopo entrano in scena i tre attori principali che si confidano l’un l’altro proprio rispetto ai sogni infantili. Il contrasto fra il filmato e la narrazione del presente è dolce/amaro, nessuno è riuscito a conservare il proprio sogno innocente.
Lo spettacolo continua con una coppia di genitori che discute dell’educazione della figlia di 4 anni. Si fanno progetti assurdi e irrealizzabili che culminano nell’unica scelta possibile: la mancanza di credibilità non può che trovare concretezza in una delle scelte dei genitori di oggi: sostituire la figura dei genitori e della scuola con i nonni spesso onnipresenti e chiamati all’educazione.
L’infanzia in chiave dolce/amara è presente anche nella quarta scena. Holly e Benji ormai adulti si telefonano e si raccontano le rispettive vite ed esperienze mostrando il lato amaro che i cartoni non svelano.
Nella quinta scena dello spettacolo si apprende che la coppia di genitori si è separata e che i due hanno una visione davvero diversa dell’educazione della figlia. Il padre in particolare è critico (a dir poco) sulla figura di Peppa Pig e per farlo capire alla figlia usa metodi poco ortodossi, quali un filmato crudo e violento e l’incontro con la realtà della macelleria. Ma la bambina ha la capacità di pensare e risponderà al padre in maniera sorprendente.
Nell’epilogo la bambina prima di addormentarsi dice alla madre di averle lasciato un bigliettino nel quale la ringrazia di farla vivere come una bambina della sua età, al contrario del padre che le fa fare delle esperienze “educative” più da adulta.
Lo spettacolo mostra come spesso, anche attraverso prodotti per l’infanzia come i cartoni, vengano veicolati messaggi e schemi che già influenzano le scelte di vita. Ma l’infanzia è un gioco serio che bisogna tutelare, come dice la madre bisogna tutelare il diritto dei bambini di giocare con fango e sporcarsi.
Rubrica di commento
“C’era una volta, in un paese lontano lontano una bambina rimasta orfana che viveva con la matrigna e le due sorellastre…”
Potrebbe sembrare la classica favola di Cenerentola, ma in Maleducazione Transiberiana il drammaturgo, Davide Carnevali, decide di raccontare alcuni aspetti tramite questa favola: la fata smemorina diventa un istituto di credito, Cenerentola indossa coco chanel,e va alla festa a bordo di un BMW guidata da un cingalese.
E infine Cenerentola la scarpetta non la perde ma dal nervoso e per la scomodità la lancia contro la vetrina della banca che le aveva concesso il prestito. Il principe al posto di girare per tutto il paese alla ricerca della ragazza che calzi la scarpa crea un talentshow grazie al quale riesce effettivamente a ritrovare Cenerentola che riesce così “a salire quei 7, 8 gradini della scala sociale. E vissero tutti felici e contenti”
Davide Carnevali, drammaturgo, racconta la vita vera per quello che è, certo in maniera anche ironica e scanzonata, ma sempre con un retrogusto amaro.
Noi crediamo che per il drammaturgo fosse molto importante non rimanere più in silenzio mettendo in atto nel modo che più lo rappresentava, cioè in maniera artistica, la sua verità.
Ha deciso di prendere parola affermando che il mondo non è solo una rappresentazione edulcorata, ma mostrando che ci sono davvero persone e situazioni in difficoltà che è giusto raccontare, cercando di essere meno egoisti e provando ad essere più empatici.
Classe 3A – Scuola Ciofs – FP/ER
(coordinamento prof. Niccolò Gozzi)
Granma. Metales de Cuba

Recensione
Quattro nonni, quattro nipoti, due generazioni ed un’unica Rivoluzione da raccontare.
Così lo spettacolo “Granma Metales de Cuba” teletrasporta lo spettatore tra gli eventi di quella che è stata la Rivoluzione cubana del 1956. A dominare il palcoscenico non sono quindi solo quattro giovani cubani, ma anche le vicende dei loro rispettivi nonni. Infatti per raccontare di Cuba i “Rimini Protokoll” hanno cercato delle storie di persone i cui nonni fossero sostenitori della rivoluzione cubana e che vi avessero partecipato in diversi modi: sessant’anni dopo, quel nodo essenziale della storia del Novecento diventa uno spettacolo teatrale che ricorda quegli eventi ufficiali, intrecciandoli con il vissuto di quattro persone e dei loro nipoti. Questa pratica di teatro civile dà vita ad uno spettacolo potente, che coagula idea, storia e individuo.
Il legame che unisce una generazione all’altra è il fulcro dell’intera narrazione. I rapporti si manifestano in modo particolare e personale a seconda degli eventi che hanno caratterizzato le vite di ognuno. I quattro giovani si propongono subito come eredi delle testimonianze dei loro nonni e, attraverso la rievocazione delle loro vite e le memorie di famiglia, viene mostrata pian piano anche la loro evoluzione personale. Il pubblico si confronta fisicamente con i quattro giovani nipoti che interagiscono virtualmente con due dei loro nonni, un veterano di guerra e la moglie di un noto musicista, attraverso dei video multimediali.
Milagro è la prima a raccontare la sua storia, è la nipote di una ex schiava, scappata dal marito, che aveva abbracciato gli ideali della rivoluzione; con la sua macchina da cucire ha mantenuto tutta la famiglia, sarta e matriarca d’eccezionale umanità. La giovane Milagro è laureata in Storia e vuole insegnarla, anche se come guida turistica guadagnerebbe in un giorno il salario di un mese come insegnante.
Poi si presenta Daniel, matematico e regista; è il nipote di un compagno di Fidel Castro, Faustino Pèrez, che aveva organizzato la traversata sulla Granma, la nave mitica che aveva portato i rivoluzionari dal Messico a Cuba; Perez ha avuto in seguito cariche politiche e per questo la sua famiglia godeva di grandi privilegi.
Prosegue la narrazione il ventiquattrenne Christian, il cui nonno fu un pilota dell’esercito e partecipò col suo caccia alla guerra in Angola; egli ha tentato di seguire le orme del nonno, ma rimane profondamente deluso dalla vita militare e si professa pacifista. Il nonno parla col pubblico e con lui: è uno dei nonni che compare nel video che interagisce con l’azione scenica.
Ultima ad entrare è Diana, una giovane musicista di trombone, che afferma di avere ereditato il suo talento dal nonno, fondatore dell’Orquestra de Florida, pur non avendolo mai frequentato: viaggiava molto, aveva molti amori ed era sempre lontano da casa, dove la moglie cresceva i figli. E’ questa l’altra nonna che interviene nella narrazione, attraverso il video in cui viene intervistata.
Così come la Granma trasportò i rivoluzionari dal Messico a Cuba, tutti i personaggi immergono il pubblico nel vivo della rivoluzione, in un vero tuffo nel passato, guidato dalle reminiscenze delle loro famiglie, con foto, canzoni e oggetti.
L’interazione tra nipoti e nonni è il passaggio chiave che permette allo spettatore di avere una visione più complessa della Rivoluzione; si assiste ad un vero intreccio tra la Storia e la sfera privata del singolo che proietta una realtà contrastante con quella ufficiale. I ricordi personali dei nonni vengono integrati da documentari, dialoghi e descrizione di foto che spiegano le varie fasi della Rivoluzione, a partire dal 1948, anno in cui sale Batista al potere, offrendo così agli spettatori la storia privata e quella pubblica, secondo diversi punti di vista.
La Storia sembra raccontata solo negli schermi, con i video d’epoca, ma i ragazzi mimano i video, entrando quasi nelle riprese e imitando anche le pose dei nonni, come se si mettessero nei loro “panni”. In più, c’è un leggio di lato sul palco, dove la Storia viene rappresentata anche con delle pedine, che interpretano i personaggi chiave della Rivoluzione cubana. Questo intrigante oggetto di scena è luogo di scenografia che viene proiettata sul grande schermo centrale, con effetto dirompente, ma diventa anche il podio per discorsi politici, declamatori o accusatori.
Un altro potente mezzo espressivo sono i tromboni, suonati dal vivo dai personaggi, che scandiscono il ritmo dello spettacolo e il passare della storia. Dei volantini vengono lanciati alla fine dello spettacolo, e ogni spettatore può leggerli e portarli con sé: ci sono frasi su cui riflettere, questioni a cui cercare di dare senso.
Sembrano il corrispettivo silenzioso delle sferzate uditive che il pubblico riceve durante lo spettacolo dal suono amplificato dei bottiglioni di plastica contro palle di calzini: questo è il modo di giocare a baseball, lo sport nazionale, nella Cuba impoverita dell’embargo. E il pubblico viene sollecitato a tirare la palla di calzini, a mettersi in gioco, diventando cubano, anche solo per un attimo.
Anche lo scorrere del tempo si materializza: una tela cucita si srotola di fronte al pubblico dalla vecchia macchina da cucire a pedale della nonna sarta e mostra lo snocciolarsi degli anni fino all’oggi, trama e ordito del tempo su cui s’imprimono le fatiche umane. Molti quesiti rimangono nell’aria…
Il pubblico si chiede se i quattro giovani raccontino veramente se stessi o i personaggi che li rappresentano: la loro vita è stata sicuramente trasformata, sono ora membri di una compagnia teatrale che si esibisce in giro per il mondo e il copione resta una fotografia del loro passato. La messa in scena di fatto traccia un solco, che lentamente si fa più profondo e allontana il racconto dalla realtà: le individualità, a contatto con molteplici realtà culturali differenti, sono inevitabilmente destinate ad evolversi, mentre le loro memorie rimangono incise nel passato e nella Storia. Come si supera quindi il confine che separa la realtà dalla finzione? E’ un quesito che riguarda ogni essere umano alle prese con la rielaborazione della propria memoria e della propria eredità.
Lo spettacolo ci mostra Cuba come archetipo delle contraddizioni tra socialismo e natura umana, prevale il tentativo di farlo attraverso una serie di esempi la cui portata è sia storica che ideologica. Dalla caduta di Ochea, accusato di narcotraffico, ai più comuni furti e giornaliere infrazioni, la rappresentazione dimostra come un ideale tanto forte da portare 82 rivoluzionari su uno yacht, il Granma, semplicemente sotto la guida della fiducia e della speranza in un mondo migliore, possa poi corrompersi una volta a contatto con il piano della realtà. Con il tempo gli ideali si dimenticano e ci si lascia sopraffare da egoistici desideri; prevale la logica del bisogno e in alcuni quella di arricchirsi, di acquisire sempre più potere, di prevalere sugli altri in modo da dimostrare la propria superiorità.
La visione aperta e problematica che ci lascia lo spettacolo parte dalla consapevolezza che il consenso universale ad una società fondata sul socialismo è forse utopia: l’individuo sarà sempre tentato dal bisogno del possesso?
Rubrica di commento
I Rimini Protokoll ci mostrano la Storia attraverso i ricordi tramandati dalla generazione che ha vissuto il periodo della Rivoluzione Cubana, alla ricerca di un ideale di libertà, identità e giustizia sociale. Ma sono i nipoti a parlarcene, mescolando documenti ufficiali a memorie familiari, attraverso il filtro dell’affetto tra nonni e nipoti. Che cosa rimane della rivoluzione dei nonni, delle lotte che hanno sostenuto, del carico di speranze, spesso infrante contro la realtà? Lo spettacolo “Granma” lancia nell’aria tanti quesiti e lascia che sia lo spettatore a cercare una risposta.
Cosa contraddistingue due concetti, storia e memoria, che all’apparenza sembrano così simili?
L’obiettivo che si pone lo spettacolo è quello di trasmettere l’ideale rivoluzionario cubano attraverso la soggettività, che è proprio ciò che differenzia il concetto di memoria da quello di storia. Le diverse storie dei personaggi e dei loro nonni ci aiutano a capire che la realizzazione del socialismo a Cuba è cambiata in base a chi lo ha vissuto e ha lottato e a chi, invece, se n’è approfittato: c’è chi ha avuto, e ancora ha, fede nell’uguaglianza politica, economica, sociale e giuridica e chi, al contrario, snatura i principi di matrice altruista, complice di corruzione e arricchimento.
Nelle storie dei nipoti ritroviamo ammirazione per i nonni e, in parte, emulazione, ma emerge chiaramente quanto sia riesce difficile assimilare lo stesso ideale per cui hanno combattuto, poiché ormai sono evidenti anche le conseguenze deludenti. Quindi la memoria che si perpetua di generazione in generazione, oltre ad essere ricca di ideali e di esperienze condivise, serve anche da filtro con cui analizzare il presente e giudicare come l’idea rivoluzionaria, ispirata a principi da tutti condivisibili, facendosi realtà abbia mostrato l’evidenza dell’egoismo umano. Appare chiaro inoltre come l’assalto del sistema capitalistico e delle sue dinamiche stia aprendo scenari inquietanti sul futuro di Cuba. Che cosa rimarrà di tutto ciò per cui i nonni hanno combattuto?
Lo spettacolo non ci dà formule risolutive o soluzioni semplici: ognuno di noi si confronta con l’archetipo che la rivoluzione cubana rappresenta, nel suo ideale e nelle sue ombre, consapevole di essere difronte ad una questione vitale per il futuro di tutti: è ancora possibile e che cosa significa, oggi, lottare contro le disuguaglianze?
Classe 5DL – ITC Mattei di San Lazzaro di Savena
(coordinamento prof.ssa Daniela Zani)
Settimo cielo

Recensione
Il primo aggettivo che viene in mente pensando a Settimo Cielo, traduzione di Cloud 9 della drammaturga inglese Caryl Churchill, è provocatorio. Lo spettacolo, diretto nella versione italiana da Giorgina Pi, stimola infatti la riflessione con il suo essere perturbante, esplicito, ribelle, mordace, punk.
L’ingresso nel teatro è avvolto da fumo denso. Gli attori attendono immobili, come pietrificati, ai lati del palco che per tutta la rappresentazione fungeranno da quinte.
Un’atmosfera surreale investe lo spettatore, che si sente proiettato in un’angusta soffitta abitata da bambole con sfarzosi abiti ottocenteschi.
Quando gli attori si risvegliano è possibile osservare come i costumi di scena rispecchino perfettamente l’immaginario comune della moda dell’epoca, eccezione fatta per pochi personaggi dei quali i vestiti fuori schema rispecchiano il desiderio di essere qualcuno che non sono.
Molti i dettagli simbolici inseriti nella scena, come la ricorrente bandiera inglese, emblema dell’orgoglio patriottico in tempo di colonialismo.
Il primo atto, inaugurato dalle note di una versione elettrica di Rule Britannia è ambientato in Africa nel 1879, in piena epoca vittoriana. Protagonista è la famiglia di un amministratore coloniale, inizialmente impettita e impeccabile, talmente autocontrollata da dialogare con filastrocche. Dall’arrivo di due nuovi ospiti l’equilibrio della finzione si rompe, rivelando i lati più oscuri di tutti i personaggi e mostrando come l’Inghilterra fosse tanto oppressore coloniale quanto oppressore etico e sessuale di se stessa. La storia si sviluppa quindi in un climax ascendente di morbosità e istinti repressi, mettendo a nudo con umorismo tagliente la sudditanza della donna, il razzismo e il nazionalismo coloniale, l’intorpidimento mentale dell’ideologia unica e il terrore con cui era vista e vissuta l’omosessualità, elemento permeante di tutta l’opera. Questo conflitto feroce tra identità intima e apparente sfocia in un folle grido di rabbia di Edward, figlioletto alle prese con la sua sessualità, preludio del grido di rabbia collettivo che fu il punk.
Nel secondo atto, nonostante il secolo di differenza, i personaggi della famiglia del primo atto sono cresciuti solo di venticinque anni.
In una realtà culturale e sociale libera come quella punk, i due giovani Edward e Victoria sviluppano una personale identità di genere e un nuovo concetto di famiglia.
La famiglia patriarcale che vediamo nel primo atto, infatti, si ritrova completamente ribaltata nel secondo, a partire dal cambio di ruoli tra gli attori stessi. Victoria è una donna emancipata che sperimenta la bisessualità con una donna e il marito, che abbandona per il suo radicato senso di dominazione sulla figura femminile. Edward prende consapevolezza della sua omosessualità e esprime il desiderio di cambiare sesso. Un altro personaggio in evoluzione è Betty, madre di famiglia sottomessa e abituata a condurre una vita noiosa e monotona, che lascia il marito per un’indipendenza e un’emancipazione mai sperimentate, riscoprendo sé stessa e piaceri dimenticati.
I costumi utilizzati sono sicuramente meno caratteristici rispetto a quelli del primo atto, ma si rivelano egualmente efficaci poiché in grado di incarnare l’idea che ci si aspetta dietro a ogni personaggio.
Caratteristica principale dell’intera rappresentazione è il cross-gender acting, recitazione da parte di attori che interpretano personaggi del genere opposto: inizialmente può far sentire spaesati, ma è inevitabile riconoscere come gli attori scelti si adattino perfettamente ai soggetti, rendendo la rappresentazione particolarmente efficace.
Caryl Churchill conduce abilmente il gioco tra provocazione e spaesamento, e sorprende fino alle ultime battute portandoci, con tono rude e mordace ma anche umoristico e leggero, dentro i grandi temi dell’identità di genere e dei rapporti di forza nelle relazioni familiari.
Rubrica di commento
IN PRINCIPIO DIO CREO’ ADAMO
“In principio Dio creò Adamo; l’uomo viveva in pace e nella gioia. In seguito creò la donna bianca, la quale si legò con il serpente e così nacquero tutti i nostri guai…”. Questa è la concezione della donna in epoca Vittoriana. Nella famiglia modello dell’800 la moglie era assoggettata al marito e passava il suo tempo al servizio della famiglia. All’interno di essa i figli venivano trattati diversamente a seconda del sesso: i maschi dovevano essere virili, rispettare e seguire la figura del padre, mentre le ragazze avevano un ruolo marginale, infatti nello spettacolo la figlia minore è interpretata da una vera e propria bambola.
Settimo cielo ci fa riflettere su quanto la comunità familiare sia cambiata nel corso del 900 e come continui a cambiare: la donna ha guadagnato diritti e libertà e si sono ridotte le differenze gerarchiche all’interno della famiglia sia tra uomo e donna, che tra genitori e figli. Nello spettacolo, a distanza di cento anni, si passa dal modello unico di famiglia alla molteplicità dell’oggi. Questo é un processo molto lento, infatti oggi siamo ancora in fase di passaggio. Ai giorni nostri solo in alcuni paesi del mondo sono accettati i matrimoni di coppie omosessuali, così come anche l’adozione. In Inghilterra, dov’è ambientato lo spettacolo, dall’assoluta intolleranza nei confronti delle coppie omosessuali si è giunti ad accettare questo orientamento persino nella famiglia reale. Nel 2018, infatti, si è celebrato il primo matrimonio gay all’interno della più nobile famiglia inglese.
Classe 3L – Liceo Scientifico Enrico Fermi di Bologna
(coordinamento prof.ssa Carla Donati)